
Trump, un piromane in una foresta
21 Luglio 2019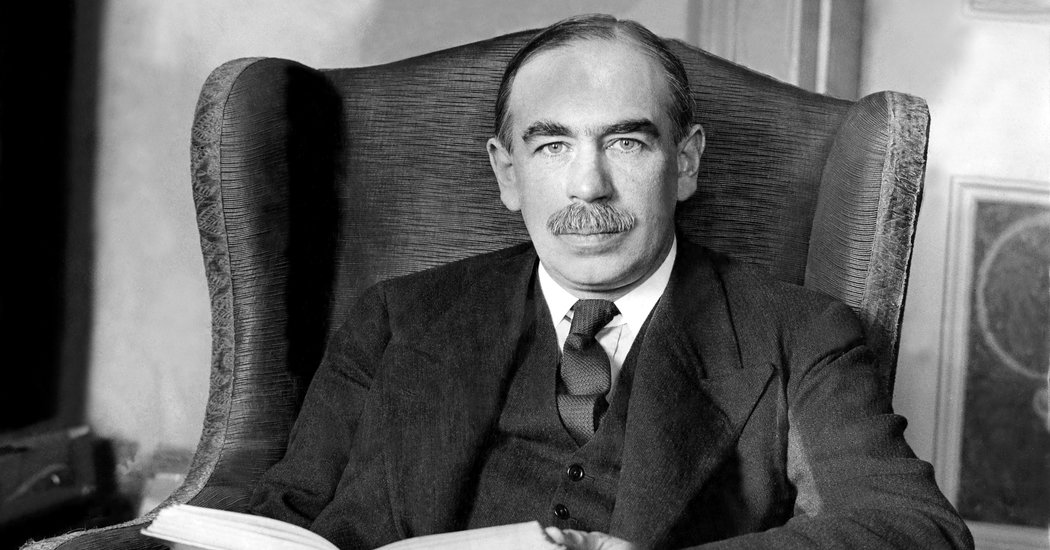
Keynes è morto! I riformisti non lo resusciteranno
21 Luglio 2019di Franco Bavila
Cenni storici
Il protezionismo non è un’invenzione di Donald Trump, ma è esistito fin dagli albori del capitalismo o, per meglio dire, è nato assieme al capitalismo. Marx ed Engels lo consideravano infatti una tappa inevitabile nello sviluppo della moderna società capitalista. Come spiegarono nei loro scritti, tra il XVII secolo e la prima metà del XIX secolo il protezionismo fu la normale politica di tutti i principali Stati europei – salvo quelli più piccoli, come i cantoni svizzeri o gli staterelli tedeschi, a causa delle loro dimensioni troppo ridotte – e fu sotto l’ala protettrice del protezionismo che in Inghilterra, tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, nacque l’industria moderna basata sulla macchina a vapore.
Secondo Marx, “Il sistema protezionistico è stato un espediente per fabbricare fabbricanti, per espropriare lavoratori indipendenti, per capitalizzare i mezzi nazionali di produzione e di sussistenza, per abbreviare con la forza il trapasso dal modo di produzione antico a quello moderno.”1
Le teorie favorevoli al libero scambio iniziarono a svilupparsi in Inghilterra solo verso la metà dell’Ottocento quando, a seguito della vittoria nelle guerre napoleoniche, la flotta inglese esercitava un dominio marittimo incontrastato e i capitalisti britannici avevano conquistato, a discapito dei loro rivali, una posizione egemonica nel commercio mondiale. A quell’epoca l’industria inglese era nettamente la più sviluppata e l’unico ostacolo che si poneva di fronte all’espansione delle esportazioni britanniche erano le tariffe doganali degli altri paesi. Le teorie liberoscambiste erano dunque finalizzate all’apertura dei mercati stranieri alle merci inglesi e presupponevano un mondo in cui l’Inghilterra godesse di una sorta di monopolio nella produzione industriale, con tutti gli altri paesi ridotti al ruolo di fornitori di prodotti agricoli e materie prime.
In questo contesto internazionale in cui l’Inghilterra era la vera e propria “officina del mondo”, il protezionismo divenne l’arma di tutti quei paesi che volevano sviluppare una propria industria nazionale. Fu per esempio il caso degli Stati Uniti, che avevano sviluppato la loro produzione manifatturiera per far fronte alle esigenze della guerra civile, ma non potevano competere alla pari con l’industria manifatturiera britannica, che aveva oltre un secolo di vantaggio. Per conquistare il loro posto nel mercato mondiale, gli Usa dovettero per forza di cose tagliare fuori dal loro mercato interno i prodotti inglesi attraverso i dazi.
Nella seconda metà dell’Ottocento il protezionismo giocò quindi una funzione importante al di fuori dell’Inghilterra, perché in una serie di paesi favorì la transizione da una società prevalentemente agricola ad un’economia incentrata sulla produzione industriale. Si trattò però di un ruolo circoscritto nel tempo e limitato alla fase iniziale di nascita del capitalismo. Già nel 1888 Engels scriveva che il protezionismo aveva oramai svolto il suo compito ed era diventato più d’intralcio che di aiuto per paesi come Stati Uniti e Germania, che avevano sviluppato un sistema industriale in grado di competere sul mercato mondiale e potenzialmente anche di superare la Gran Bretagna.
All’inizio del XX secolo l’egemonia britannica era stata sostituita dallo scontro per la supremazia tra un numero ristretto di potenze imperialiste (Germania, Stati Uniti, Inghilterra, Francia…) e in questa lotta i dazi commerciali svolgevano un ruolo tutto sommato marginale; ad essere decisive erano soprattutto le dimensioni dei grandi gruppi monopolistici in competizione tra loro, il livello di capitali che le banche erano in grado di investire sui mercati esteri e il potere economico-militare di ciascuno Stato. Come scrisse Lenin: “(…) Non è più la lotta del libero commercio contro la protezione doganale e la dipendenza coloniale, bensì di un imperialismo contro un altro, d’un monopolio contro un altro, di un capitalismo finanziario contro un altro.”2
Il protezionismo tornò protagonista solo dopo la Prima guerra mondiale e soprattutto dopo la crisi del 1929, la recessione più profonda sperimentata dal mondo capitalista, perlomeno fino a quel momento. Nel corso degli anni ’30 le politiche protezioniste fiorirono in tutto il mondo capitalista, ma il contesto in cui vennero applicate era radicalmente diverso rispetto al passato. Se nell’Ottocento il protezionismo aveva accompagnato l’ascesa del modo di produzione capitalista, negli anni ’30 si tentò di utilizzarlo per porre rimedio a una fase di declino e crisi profonda.
Gli USA
La spinta verso il protezionismo negli Usa cominciò ancora prima della crisi del 1929. A quei tempi il partito repubblicano era il più protezionista, in quanto esprimeva tradizionalmente soprattutto gli interessi dell’industria manifatturiera nel Nord del paese, che soffriva maggiormente la concorrenza dei prodotti finiti importati dall’estero; i democratici erano invece favorevoli al libero scambio, essendo maggiormente legati a quei settori dell’economia orientati verso l’export, come i produttori di tabacco e cotone negli Stati meridionali. Negli anni immediatamente precedenti alla Prima guerra mondiale, l’amministrazione democratica aveva stabilito un sistema di dazi particolarmente bassi, ma nel 1922 la nuova maggioranza repubblicana al Congresso approvò il Fordney-McCumber Tariff Act (dal nome dei suoi promotori al Congresso), che prevedeva un aumento della tariffa media sui beni importati di ben il 64%.
La corsa verso dazi sempre più alti era però appena cominciata. Già durante la campagna elettorale del 1928, i repubblicani promisero una nuova revisione del sistema di tariffe. Si trattava di una mossa volta soprattutto a conquistare il voto degli agricoltori. Sebbene infatti per gran parte degli anni ’20 gli Stati Uniti avessero vissuto un periodo di crescita economica, in quello stesso periodo l’agricoltura americana (che all’epoca impiegava ancora un quarto della forza lavoro complessiva) aveva attraversato una crisi profonda. Durante la Prima guerra mondiale c’era stata un’enorme richiesta di prodotti agricoli americani e, per soddisfare la domanda, molti contadini si erano indebitati per realizzare una serie di investimenti nelle loro fattorie; tuttavia dopo la guerra era seguito un crollo dei prezzi e una recessione nel settore agricolo. Tra il 1926 e il 1929 il 18% delle fattorie venne pignorato e numerose banche rurali dichiararono fallimento.
Le associazioni agrarie iniziarono a lamentare di essere discriminate rispetto all’industria, che invece andava a gonfie vele ed era maggiormente protetta grazie a dazi mediamente doppi rispetto a quelli sui prodotti agricoli. I contadini rivendicavano parità di trattamento e i repubblicani promisero loro che avrebbero alzato i dazi agricoli. Ma una volta messo in moto il dibattito parlamentare sul sistema tariffario nel gennaio del 1929, quella che doveva essere una revisione limitata delle tariffe agricole, si trasformò rapidamente in una revisione generale che interessava soprattutto i dazi sui prodotti industriali.
Le apposite commissioni del Congresso tennero audizioni con più di mille persone, in massima parte rappresentanti delle piccole e medie imprese che faticavano a sopravvivere sul mercato interno e rivendicavano un aumento dei dazi su singoli prodotti molto specifici. Sia la Camera che il Senato votarono punto per punto su una lista di più di tremila prodotti: fu il tripudio delle attività lobbistiche e del voto di scambio, che fecero andare fuori controllo il processo di revisione e portarono all’innalzamento di un gran numero di tariffe. La leadership repubblicana non cercò affatto di porre un argine, anzi i lavori parlamentari erano diretti da due fanatici sostenitori del protezionismo, il deputato Willis Hawley e il senatore Reed Smoot. Quest’ultimo, che curiosamente era anche un “apostolo” della chiesa mormone, era soprannominato “l’apostolo dello zucchero”, per aver dedicato la sua intera carriera politica alla protezione dell’industria dello zucchero del suo Stato di origine, lo Utah.
Obiettivamente in quel periodo, sul piano economico, gli Stati Uniti non avevano affatto bisogno di una maggior protezione doganale. Il Pil cresceva, la disoccupazione era al minimo, le tariffe erano già molto alte e nell’import-export gli Usa avevano un surplus commerciale di 1,4 miliardi di dollari. Tuttavia il protezionismo aveva assunto una dinamica tutta propria, già descritta da Engels: “Il protezionismo è, nella migliore delle ipotesi, un circolo vizioso senza fine e non si sa mai quando finisce. Proteggendo un settore, si danneggiano direttamente o indirettamente tutti gli altri, e quindi si devono proteggere anche loro. Ma in questo modo si danneggia di nuovo il settore che era stato protetto all’inizio che richiederà degli indennizzi, e questi indennizzi avranno effetti, come nel primo caso, su tutti gli altri settori, giustificando le loro richieste di indennizzo e così via all’infinito.”3
Nel bel mezzo dell’iter legislativo sulle nuove tariffe, nel mese di ottobre del 1929 ci fu il famoso crollo di Wall Street. La recessione che ne seguì indubbiamente contribuì ad alimentare la spinta al rialzo dei dazi commerciali, nella speranza che una maggior protezione doganale potesse favorire la ripresa dell’economia americana. Sintomatica di questo modo di pensare fu la dichiarazione del senatore repubblicano Frank Crowther al momento del voto finale: “Una volta che il progetto diventerà legge, la fiducia nel mondo degli affari verrà immediatamente ripristinata. Gradualmente ci tireremo fuori dalla recessione temporanea degli ultimi mesi e ancora una volta la prosperità regnerà sovrana.”4
Nel mese di giugno del 1930, dopo una gestazione di un anno e mezzo, il Congresso approvò definitivamente lo Smoot-Hawley Tariff Act, che nella sua versione finale innalzava ulteriormente i dazi su ben 887 merci. La tariffa media sui prodotti importati venne alzata di un ulteriore 16% rispetto a quella già molto alta del 1922 e raggiunse il livello più alto negli Usa dal 1830. Per paradosso i dazi sui prodotti industriali furono aumentati molto di più di quelli sui prodotti agricoli, il che peraltro contribuì a rendere ancora peggiore la condizione dei contadini, che si trovarono a pagare prezzi più alti per i prodotti di cui avevano bisogno nelle loro fattorie.
La nuova legge incontrò l’opposizione di una parte significativa della grande borghesia americana, quella che dipendeva maggiormente dalle esportazioni ed era più legata al sistema finanziario mondiale. Per esempio i colossi dell’industria automobilistica come Ford e General Motors, che esportavano auto in tutto il mondo, temevano ritorsioni da parte degli altri paesi. Anche una grande banca come JP Morgan era preoccupata del fatto che una contrazione del commercio mondiale potesse compromettere la capacità dei paesi europei di pagare i debiti di guerra che avevano contratto con gli Usa.
Proprio i timori per le ripercussioni internazionali furano al centro di un appello, sottoscritto da ben 1.028 economisti o professori di economia provenienti da 179 università e college, affinché il presidente Hoover ponesse il veto alla legge Smoot-Hawley. La petizione degli economisti non venne tuttavia ascoltata dalla maggioranza del padronato industriale, il cui pensiero fu ben sintetizzato dalle rozze parole del senatore repubblicano Samuel Shortridge: “Non sono né impaurito né affatto preoccupato per il proclama di questi professori che non hanno mai guadagnato un dollaro con un lavoro onesto, con il sudore della loro fronte…”.5 E così Hoover, che prima di essere stato presidente aveva guadagnato milioni di dollari con le concessioni minerarie, controfirmò la nuova legge il 17 giugno 1930.
La crisi del 1929
Il crack del 1929 fu devastante per gli Usa. Nel giro di quattro anni il Pil crollò del 25%, la produzione industriale del 55%. I disoccupati passarono da essere 2 milioni nel 1928 a 15 milioni nel 1933. Gli Stati Uniti già all’epoca erano la principale potenza economica a livello mondiale e la recessione si estese rapidamente agli altri paesi. Sarebbe però errato ritenere, come fanno ancora oggi molti politici ed economisti ultraliberisti, che la Grande Depressione sia stata provocata dal protezionismo. La crisi aveva le sue origini nelle contraddizioni più profonde e ineludibili dello stesso sistema capitalista.
Alan Woods ha così sintetizzato la situazione economica che portò alla crisi del ’29: “Marx spiega che la causa fondamentale di ogni vera crisi capitalista è la sovrapproduzione. L’industria degli pneumatici negli Usa si era espansa ben oltre quella che era la domanda di copertoni. I calzaturifici avevano una capacità produttiva di circa il doppio degli acquisti effettivi di scarpe nel paese. I due terzi della capacità potenziale nella produzione di farina erano superflui. Sarebbe stato possibile chiudere circa il 40% dell’industria americana dell’acciaio e nessuno (eccetto i lavoratori licenziati) avrebbe notato la differenza. E così via. Quando la borsa alla fine crollò nell’ottobre del 1929, non fu questa la causa della Grande Depressione, come generalmente si dà per scontato, ma solo un sintomo dei problemi alla base dell’economia reale e un avvertimento che il peggio doveva ancora venire.”6
Più che una causa, il protezionismo fu una delle conseguenze della recessione, ma è indiscutibile che giocò un ruolo importante nell’approfondire una crisi già di suo molto grave. Gli Usa infatti furono solo i primi a mettere in atto una politica protezionista all’inizio degli anni ’30, tutti gli altri paesi capitalisti li seguirono nel giro di breve tempo. È questa infatti una delle caratteristiche del protezionismo: se un paese si pone decisamente su quella strada, il resto del mondo non resta a guardare ma adotta le sue contromisure. Fu proprio quello che accadde a livello internazionale a seguito dell’approvazione dello Smoot-Hawley Tariff Act.
Già durante il dibattito al Congresso, più di trenta paesi avevano inviato a Washington note di protesta, minacciando ritorsioni in caso di aumento dei dazi, ma i parlamentari repubblicani dalla mentalità ristretta non avevano dato peso alla cosa. Come dichiarò Smoot: “Le tariffe sono una questione interna e le tariffe americane devono essere formulate e poste in esecuzione dal Congresso e dall’amministrazione americana. Nessun paese straniero ha il diritto di interferire.”7
Paradossalmente l’aumento delle tariffe americane avvenne mentre diversi paesi europei stavano cominciando a loro volta ad entrare in recessione e stavano cercando di negoziare presso la Società delle Nazioni (l’antesignana dell’Onu) una “tregua tariffaria”. Dopo l’approvazione della legge Smoot-Hawley questi tentativi vennero abbandonati e a livello internazionale prevalse la linea “ciascuno per sé”.
Il Canada
Il primo paese a reagire fu il Canada. Nel 1929 il 43% dell’export canadese era destinato agli Usa, mentre il Canada assorbiva il 18% delle esportazioni americane. I due paesi erano molti interdipendenti tra loro e uno era il principale partner commerciale dell’altro. Le esportazioni costituivano il 26% del Pil del Canada, che dunque era particolarmente sensibile riguardo al suo accesso al mercato americano.
Di fronte all’innalzamento delle barriere tariffarie americane, il governo liberale di Mckenzie King iniziò a trasferire i suoi commerci dagli Stati Uniti all’Impero britannico: alzò le tariffe su 16 prodotti che rappresentavano il 30% dell’export americano in Canada e ridusse i dazi su 270 prodotti provenienti dalla Gran Bretagna e dalle sue ex colonie.
Ma questo non fu sufficiente e nel luglio del 1930 i liberali, considerati troppo filo-americani, persero le elezioni, superati dal partito conservatore che in campagna elettorale aveva alzato la bandiera del nazionalismo economico nei confronti degli Usa. Il nuovo governo portò avanti una seconda ondata, più consistente, di aumenti dei dazi commerciali su un gran numero di beni, provenienti soprattutto dagli Usa. In sei mesi, nella seconda metà del 1930, le esportazioni Usa in Canada crollarono del 41%.
L’Europa
In Europa molti paesi, che non si erano ancora completamente ripresi dalla Prima guerra mondiale e ora erano attanagliati da una pesante crisi finanziaria, effettuarono ritorsioni commerciali nei confronti degli Usa dopo l’entrata in vigore dello Smoot-Hawley Tariff Act e iniziarono a condurre una politica apertamente protezionista.
Germania e Ungheria, di fronte alla crisi delle loro banche, imposero il controllo dei cambi, soprattutto per impedire fughe di capitali, ma anche per ridurre la spesa nelle importazioni. A partire dal 1931 la Germania iniziò a recidere i legami commerciali con gli Usa attraverso una serie di strumenti restrittivi, come le licenze di importazione, e tramite una serie di accordi bilaterali instaurò un sistema tariffario agevolato con i paesi dell’Europa sud-orientale. Di conseguenza la quota Usa di importazioni in Germania passò dal 15% nel 1928 al 6% nel 1935.
La Francia alzò i livelli dei dazi sulle automobili, che all’epoca provenivano quasi esclusivamente dagli Stati Uniti, e introdusse quote di importazione. Nel 1936 quasi i due terzi dell’import francese erano limitati dalle quote importazione, che penalizzavano soprattutto i prodotti americani. La quota di importazioni dagli Usa passò infatti dal 12% nel 1928 al 9% nel 1935.
La Spagna impose dazi molto pesanti sulle automobili, che portarono ad un crollo del 94% dell’esportazioni di auto americane in Spagna. Le auto americane vennero rimpiazzate da quelle prodotte in Gran Bretagna, Canada e Germania. La Spagna colpì con tariffe più alte un’altra serie di prodotti che in larga misura erano importati dagli Usa: lamette da barba, macchine da cucire, pneumatici, pellicole… In un solo mese, settembre 1930, l’export americano in Spagna crollò del 54%.
Anche l’Italia raddoppiò i dazi sulle auto straniere – l’ 80% delle auto importate in Italia erano americane. Vennero alzate anche le tariffe sugli apparecchi radio, che pure in massima parte erano prodotti negli Usa. L’Italia iniziò poi ad acquistare le materie prime di cui aveva bisogno non più dagli Stati Uniti, ma da altri paesi. Ad esempio iniziò a rifornirsi di grano dalla Russia. Così la quota americana nelle importazioni italiane si ridusse dal 18% nel 1929 all’11% nel 1935.
La Svizzera, che esportava negli Stati Uniti il 20% della sua produzione di orologi ed era stata molto colpita dall’aumento dei dazi americani, diede vita a una campagna di boicottaggio contro i prodotti americani (automobili, macchine da scrivere, ecc.) e adottò quote di importazioni penalizzanti per gli Usa. L’import svizzero dagli Stati Uniti crollò del 30% nel 1930. La quota di importazioni svizzere provenienti dagli Usa calò dal 9% nel 1928 al 6% nel 1935.
La Gran Bretagna
Anche la Gran Bretagna, da un secolo fautrice del libero scambio, si volse al protezionismo. Nel 1931 i conservatori ritornarono al potere propugnando una politica protezionista. Nel 1932 venne introdotta una tariffa generale del 10% sulla maggior parte delle importazioni. Se nel 1930 il 70% delle importazioni dagli Usa entrava in Gran Bretagna senza alcun dazio, questa quota un anno più tardi si era abbassata a solo il 20%. Nel corso del 1932 la Gran Bretagna effettuò una svolta nella sua politica commerciale, stabilendo tariffe preferenziali con le sue ex colonie (Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sud Africa) e con le sue colonie dotate di autonomia doganale (India). Questi paesi ottennero un accesso preferenziale per i loro prodotti agricoli e le loro materie prime sul mercato britannico e in cambio concessero accesso agevolato ai prodotti manifatturieri inglesi sui loro mercati. Nel luglio-agosto del 1932 si tenne una conferenza internazionale a Ottawa, promossa dal governo conservatore canadese, in cui la Gran Bretagna accettò un sistema di preferenze commerciali all’interno dell’Impero britannico. Canada e Gran Bretagna costituivano i due principali mercati dell’export statunitense e assieme assorbivano un terzo delle esportazioni americane nel 1929. Dopo l’introduzione del sistema preferenziale, gli Usa vennero in larga parte tagliati fuori dal commercio all’interno del Commonwealth. Tra il 1929 e il 1933 la quota di importazioni americane passò dal 69% al 54% in Canada e dal 16% all’11% in Gran Bretagna.
La Gran Bretagna inoltre, nel settembre del 1931, abbandonò la parità con l’oro della sua moneta (ai tempi in vigore in quasi tutti i paesi) e lasciò che la sterlina si deprezzasse sul mercato dei cambi rispetto alle altre valute. La svalutazione della sterlina rese i prezzi delle esportazioni britanniche più competitivi sul mercato mondiale e le importazioni meno convenienti. Questa mossa britannica provocò un profondo logoramento delle relazioni commerciali internazionali. Da una parte alcuni paesi, come quelli scandinavi la cui moneta era legata alla sterlina, lasciarono che anche le loro valute si deprezzassero. Dall’altra i paesi che avevano mantenuto lo standard aureo furono costretti a imporre il controllo dei cambi per impedire una fuga di capitali. Tra settembre e ottobre del 1931 a imporre il controllo sui cambi furono Uruguay, Colombia, Grecia, Cecoslovacchia, Islanda, Bolivia, Jugoslavia, Austria, Argentina e Belgio. Altri paesi risposero alla svalutazione competitiva imponendo barriere commerciali più alte contro i paesi che avevano deprezzato la loro moneta. La Francia impose un aumento del 15% sui prodotti britannici e all’inizio del 1932 anche l’Olanda, da sempre liberoscambista, aumentò i dazi del 25% per compensare il vantaggio competitivo dei produttori inglesi.
Le conseguenze del protezionismo
Complessivamente all’inizio degli anni ’30 ben cinquanta paesi aumentarono i dazi commerciali, mentre quote di importazione o altri meccanismi di restrizione (proibizioni, sistemi di licenze, ecc.) furono imposti in trentadue paesi. Questo ebbe conseguenze devastanti sul commercio mondiale, che tra il 1929 e il 1932 subì una contrazione del 25%, il che a sua volta contribuì ad aggravare pesantemente la Grande Depressione. I più penalizzati in questa situazione furono proprio gli Usa, che avevano dato il via alla corsa verso il protezionismo: le esportazioni americane nel mondo crollarono complessivamente del 49% e la quota americana dell’export mondiale passò dal 15,6% nel 1929 al 12,4% nel 1932. Se nel 1929 le esportazioni rappresentavano il 5% del Pil americano, nel 1931 questa quota era precipitata all’1,5%.
Nonostante questi dati economici incontrovertibili, gli Usa non riuscirono a liberarsi facilmente dalla spirale protezionista che avevano messo in moto. I dazi rimasero in vigore anche quando alle elezioni del 1932 i repubblicani vennero battuti sonoramente – sia Smoot che Hawley persero i loro seggi – e vinsero i democratici di Roosevelt, che si erano opposti al nuovo sistema di tariffe. Ma con la disoccupazione alle stelle e gli altri paesi che stavano innalzando barriere doganali contro gli Usa, nemmeno i democratici poterono portare avanti una riduzione unilaterale delle tariffe.
Il nuovo Congresso si limitò a votare una legge che dava al Presidente l’autonomia di modificare le tariffe per raggiungere accordi commerciali con altri paesi. Nel corso degli anni ’30 l’amministrazione Roosevelt raggiunse effettivamente accordi con una dozzina di paesi e in conseguenza alcune delle tariffe vennero abbassate, ma si trattò di risultati molto limitati e gli Usa non riconquistarono la loro precedente posizione sul mercato mondiale. In realtà le barriere protezioniste non vennero liquidate che dopo la Seconda guerra mondiale, quando gli Usa si trovarono in una situazione simile a quella della Gran Bretagna un secolo prima: grazie alla vittoria nella guerra avevano conquistato una posizione di indiscussa supremazia politico-militare nel mondo capitalista e ora avevano bisogno di un sistema globale di libero scambio per egemonizzare i mercati mondiali con le loro merci.
Quanto esposto dimostra come il protezionsimo non sia affatto un modo per ovviare alle contraddizioni del capitalismo, ma non faccia altro che esacerbarle. Secondo Marx l’espansione del commercio mondiale era uno dei modi con cui i capitalisti potevano ritardare – ma non evitare – le crisi di sovrapproduzione. Al contrario il protezionismo, contraendo il commercio mondiale, non fa altro che accelerare le crisi. Se questo era vero negli anni ’30, lo è molto di più nel mondo di oggi, dove i commerci internazionali sono molto più sviluppati e i diversi paesi sono incomparabilmente più interdipendenti tra loro. Basti pensare che nel 1929 la percentuale del Pil americano derivante dalle esportazioni era il 5%, mentre oggi è circa il 12%, e nel periodo 2011-2014 ha superato il 13,5%.
A suo tempo Marx ed Engels si espressero a favore del libero scambio, non certo aderendo agli argomenti della propaganda liberoscambista dell’epoca (che anzi sottoposero costantemente a critica sferzante), ma per ragioni rivoluzionarie. Ritenevano infatti che il libero scambio avrebbe consentito lo sviluppo più rapido possibile delle forze produttive e con esse le condizioni per il superamento del capitalismo stesso. Se leggiamo il Discorso di Marx sul libero scambio del 1848, il 99% del testo è dedicato a contestare la propaganda ufficiale liberista e poi si conclude così: “In generale attualmente il protezionismo è misura conservatrice, mentre il libero scambio agisce come forza distruttiva. Esso distrugge le vecchie nazionalità e spinge agli estremi l’antagonismo fra proletariato e borghesia. Il libero scambio affretta la rivoluzione sociale. È solo in questo senso rivoluzionario, o signori, ch’io voto pel libero scambio.”
Diversamene dai tempi di Marx ed Engels, nella nostra epoca il capitalismo non ha più bisogno di svilupparsi. Non solo si è già interamente sviluppato, ma è anche entrato in una fase di decadenza, in cui i periodi di crisi sono prolungati e devastanti, mentre i periodi di ripresa hanno il fiato corto. Né il liberismo né il protezionismo possono riportare indietro le lancette dell’orologio all’epoca d’oro del boom. E dunque la “rivoluzione sociale” e la “distruzione del sistema” di cui scrivevano Marx ed Engles sono ancor più necessarie oggi di quanto lo fossero allora.
Note
- Karl Marx, Il Capitale, Editori Riuniti, p. 819
- Lenin, L’imperialismo fase suprema del capitalismo, Editori Riuniti, p. 156.
- Friedrich Engels, Prefazione all’edizione inglese del discorso di Marx sulla questione del libero scambio, 1888, disponibile su www.marxismo.net.
- Cit. in Douglas A. Irwin, Peddling Protectionism, Smoot-Hawley and the Great Depression, Princeton University Press 2011, p. 76.
- Ibidem, pp. 85-86.
- Alan Woods, Marxism and the Usa, Wellred Books 2005, p. 94.
- Douglas A. Irwin, op. cit., p. 149.

