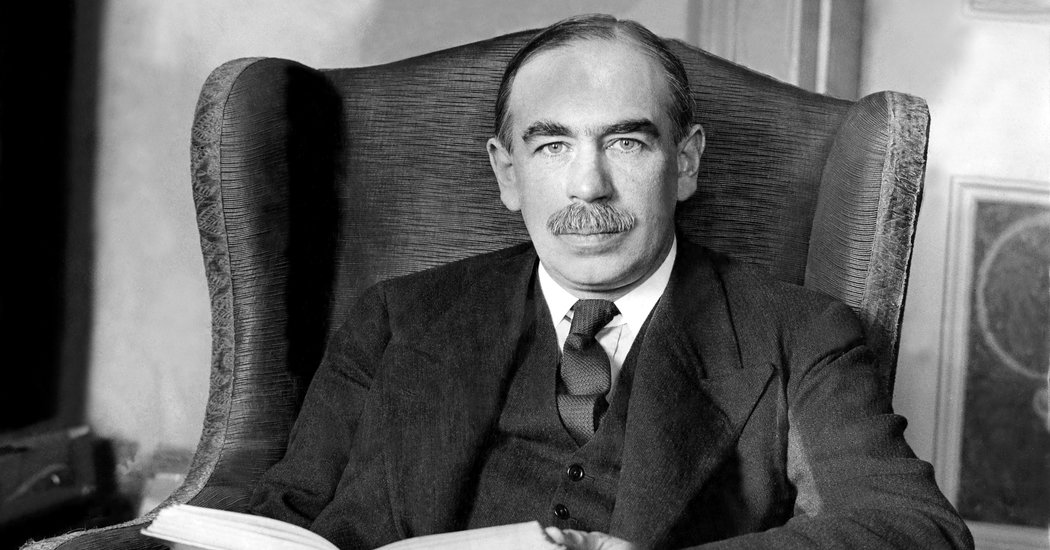
Keynes è morto! I riformisti non lo resusciteranno
21 Luglio 2019
La rivoluzione artistica del Maggio francese
21 Luglio 2019La Cina è vicina… a dominare il mondo? – La via della seta e i nuovi equilibri internazionali

di Alessandro Giardiello
Le aggressive politiche protezionistiche di Trump, con l’introduzione di pesanti dazi contro la Cina aprono numerosi interrogativi sul ruolo di Pechino all’interno dei nuovi equilibri internazionali. È la Cina un competitor in grado di mettere in discussione il dominio americano sul globo o ci troviamo di fronte a un paese sostanzialmente dipendente
dall’imperialismo occidentale?
Le reazioni annunciate da Xi Jinping alle misure dell’amministrazione americana escluderebbero la seconda ipotesi in quanto non mostrano alcuna volontà da parte dei cinesi di piegarsi alla volontà di Trump.
La Cina per ovviare alla riduzione delle vendite negli Usa sta intensificando le relazioni commerciali con l’Unione europea e il resto del mondo. La via della seta (One belt one road) è la risposta che Pechino ha messo in campo per dare un ulteriore salto di qualità ed affermarsi come nuovo gigante dell’economia mondiale.
Secondo il Center for China and Globalization l’esportazione cinese di capitale nel 2015 aveva superato il capitale straniero nel paese; gli investimenti diretti esteri ammontavano a 145,6 miliardi di dollari, mentre il capitale estero in Cina era di 135,6 miliardi di dollari.1
Secondo il Financial Times, nel 2017 la Cina risulta essere il più grande esportatore di capitale in Africa, per la maggior parte al fine estrattivo di risorse naturali.2
Per quanto riguarda l’energia, come anche in altri settori, quali ad esempio le comunicazioni, va segnalata la presenza di monopoli, tra cui la China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec, quarta società al mondo per ricavi nel 2015) e la China National Petroleum Corporation (Cnpc, terza società al mondo per ricavi nel 2015), che rappresentano due società internazionali tra le maggiori al mondo nel campo del petrolio e del gas. Infine il settore bancario cinese vanta ben 4 delle 10 banche più potenti al mondo, tra cui la maggiore è la Industrial and Commercial Bank of China (la più grande banca al mondo per capitale).
Quella che negli anni ’90 era una piattaforma produttiva per gli investimenti delle multinazionali straniere è ormai una potenza economica mondiale che compete sui mercati internazionali e che, come abbiamo avuto modo di sostenere in altri testi, svolge un ruolo imperialista su scala globale.3
Un capitalismo che sviluppa le forze produttive?
È convinzione piuttosto diffusa che la Cina, a partire dagli anni ’80, abbia attratto capitali stranieri fondamentalmente grazie alle sue enormi riserve di manodopera a buon mercato. Si tratta di una spiegazione in generale corretta, ma molto parziale.
Il mondo è pieno di serbatoi di manodopera a basso costo che non hanno attratto la stessa quantità di investimenti che si sono riversati in Cina negli ultimi trent’anni.
Il punto non è solo che fosse a buon mercato ma anche che c’erano condizioni favorevoli per quanto riguarda la qualità di questa manodopera oltre alla possibilità di innescare in tempi rapidi un impressionante ciclo di espansione produttiva di cui siamo stati spettatori in questi anni.
Se questo è stato possibile il merito non è da attribuirsi al capitale internazionale, che alla fine degli anni ’70 nuotava in pessime acque, ma alla base economica, sociale e culturale costruita dallo Stato operaio nato dalla rivoluzione del 1949, nonostante le molte distorsioni esistenti.
Ciò nonostante, rapporti di forza sfavorevoli sul piano internazionale, attribuibili alla sconfitta del movimento operaio occidentale negli anni ’80 e alla profonda crisi dei regimi a “socialismo reale”, producevano un fenomeno contradditorio, peculiare ed imprevisto.
Le economie nazionalizzate che per tutta una fase storica erano state in grado di sviluppare le forze produttive a livelli di gran lunga superiori a quelli del capitalismo, entrarono in crisi fondamentalmente per il ruolo di una burocrazia parassitaria che si appropriava della gran parte della ricchezza creata dalla classe operaia, diventando un ostacolo assoluto allo sviluppo delle forze produttive. L’assenza di un piano gestito democraticamente dal basso divenne improponibile quando l’economia sovietica raggiunse un maggior livello di complessità.
Avvenne così che il capitalismo che negli anni ’70-’80 era in crisi di sovrapproduzione invece di soffrire la convivenza con le economie pianificate degli Stati operai e subirne l’egemonia, come era avvenuto per più di mezzo secolo dopo la Rivoluzione d’ottobre, addirittura se ne avvantaggiava quando i sistemi dell’Est si aprivano al mercato mondiale, nel vano tentativo di risolvere una crisi che dipendeva dall’assenza di democrazia operaia e non certo dall’assenza di capitalismo.4
Se il processo in Urss assunse un carattere rovinoso con il tracollo del regime stalinista avvenuto tra l’agosto e il dicembre del 1991, in Cina l’operazione, governata in maniera più graduale dal vertice del Partito comunista cinese (Pcc), ottenne risultati economici positivi seppure con un costo umano gigantesco pagato dalla classe operaia, in termini di sfruttamento e di autoritarismo.
Il Pcc non seguì la linea gorbacioviana ma quella dei carri armati e della repressione del movimento di piazza Tien An men (giugno 1989) e ha governato con il pugno di ferro contro ogni tipo di opposizione venisse dalla classe lavoratrice e dai giovani cinesi.
Per una serie di circostanze storiche particolari avvenne quello che nessun marxista aveva previsto e cioè che in Cina il capitalismo venisse restaurato, senza che questo producesse un tracollo delle forze produttive (come era stato previsto da Trotskij e da altri e come è effettivamente avvenuto in Urss).5
Non solo in Cina non c’è stato alcun tracollo, ma nelle particolari condizioni che si realizzavano alla fine del XX secolo, si sono visti livelli di crescita impressionanti simili a quelli che erano stati realizzati negli anni ’50 e ’60 in epoca maoista.
È anche per questo che alcuni sedicenti marxisti negano l’avvenuta restaurazione del capitalismo in Cina e considerano Pechino una forma interessante di “socialismo di mercato”.
Si tratta di un socialismo molto particolare quello dove, secondo la rivista Forbes, sono presenti ben 400 miliardari (in dollari), che detengono 950 miliardi.6 Questi dati pongono la Cina al secondo posto tra gli Stati al mondo con più miliardari, seconda solo agli Stati Uniti, che nel 2016 ne contavano 540,6 e testimoniano come l’accentramento della ricchezza nel paese abbia raggiunto livelli impressionanti.
Secondo la Chinese Sociological Review, nel 2012 l’1% della popolazione cinese possedeva oltre il 33% della ricchezza, mentre il 25% più povero meno del 2%.7
Oggi si contano quasi 300 milioni di nongmingong, termine ambiguo e paradossale che sostituisce l’appellattivo di “teppaglia” (liumang), vale a dire operai, provenienti dalle campagne, che vagano di cantiere in cantiere, di fabbrica in fabbrica, di megalopoli in megalopoli, sottopagati, senza tutele sociali e previdenziali, che non possono acquistare una casa in città per i costi stellari dovuti alla speculazione, né possono tornare al villaggio d’origine. Sono proprio loro il prodotto cristallino e più autentico delle magnifiche sorti progressive del socialismo cinese.
Da Mao a Xin Jinping, la marcia verso il capitalismo
Dopo la morte di Mao, liquidato il gruppo dei suoi sostenitori della “banda dei quattro”, la burocrazia del Pcc decise di guidare la restaurazione al capitalismo sotto un ferreo controllo del partito e dello Stato.
Deng Xiao Ping elaborò la teoria del socialismo di mercato, o “socialismo con caratteristiche cinesi”.
Molti sostenitori delle attuali politiche della Cina paragonano le riforme di Deng con la Nuova politica economica (Nep), applicata da Lenin e i bolscevichi nell’Urss che usciva dissanguata dalla guerra civile.
Si tratta di una rappresentazione falsa: la Nep fu un provvedimento assunto in condizioni eccezionali dallo Stato operaio che doveva avere un carattere transitorio e di breve durata, prevedeva delle limitate concessioni ai kulaki (proprietari di terra) al fine di ripristinare l’industria nazionale, devastata dalla guerra, e si realizzava nel quadro della dittatura del proletariato, con il monopolio del commercio estero e una nazionalizzazione completa delle banche e dell’economia (il settore privato consentito non coinvolgeva i grandi mezzi di produzione ma solo i piccoli).
Il caso della Cina è molto differente e non per aspetti secondari.
Se Deng inaugurava le Zone economiche speciali (Zes), nelle quali, a partire dal 1979, specifiche legislazioni economiche favorivano e incoraggiavano l’afflusso di capitale proveniente dall’estero, Jiang Zemin nel 2000 ideava la “teoria delle tre rappresentanze”, che di fatto forniva alla nuova borghesia legittimazione politica e sociale. Secondo tale teoria, infatti, il partito doveva rappresentare anche gli imprenditori, non più soltanto i contadini e le masse lavoratrici. Il Pcc abbandonava anche formalmente il principio della lotta di classe. Veniva così formalizzato l’ingresso di elementi borghesi all’interno del partito.
Per meglio comprendere l’importanza che le imprese private assumono oggi in Cina, basta esaminare alcune cifre riguardanti il peso del settore privato nello Stato a seguito delle privatizzazioni massicce applicate da Deng in poi: nel 2005 il numero di imprese private ammontava a 4,3 milioni, nel 2010 a 7,5 milioni e nel 2015 a 12 milioni, mentre nello stesso anno le imprese statali erano 2,3 milioni; attualmente circa il 70% della produzione industriale cinese è dovuta a imprese non statali, oltre l’80% della forza-lavoro industriale è impiegata nel settore privato e solo il 13% dei lavoratori urbani sono dipendenti statali; inoltre la crescita delle imprese private è di gran lunga superiore a quella delle imprese statali (negli ultimi tre decenni il 95% dell’aumento della forza-lavoro urbana è dovuta a compagnie private).8
È dunque evidente come in Cina il ritorno al capitalismo sia pressoché completo, per quanto sotto le forme di un capitalismo di Stato.
Si tratta tuttavia di un capitalismo di tipo particolare. Nonostante la pervasività del mercato mondiale e la grande quantità di investimenti stranieri la burocrazia cinese è sempre riuscita a non sottomettersi ai meccanismi di dipendenza tipici dei paesi semi-coloniali nei confronti dell’imperialismo occidentale.
Questo si deve, da una parte alle dimensioni economiche e territoriali della Cina, in secondo luogo al fatto che essendo uno Stato in transizione esiste una sovrastruttura politica onnipresente ed estremamente radicata rappresentata dal Partito comunista che ha fatto di tutto per mantenere le principali leve economiche sotto il proprio controllo, riuscendo a condizionare le aziende private attraverso molteplici canali (ad esempio orientando agevolazioni, permessi, finanziamenti, ecc.).
Ma non è tutto. La burocrazia del partito ancor prima di rivolgersi al capitale straniero, ha coscientemente favorito il rafforzamento di una borghesia indigena basandosi sui capitalisti della diaspora cinese (Hong Kong, Macao e persino Taiwan). Questa alleanza, voluta da Deng, con i capitalisti cinesi di oltremare si rivelerà estremamente fruttuosa da ambo le parti e svolgerà un ruolo fondamentale nel limitare lo strapotere dei capitalisti occidentali.
Rispetto alle multinazionali europee e nordamericane i cinesi di oltremare sono arrivati prima e sono stati in grado di aggirare molti aspetti della legislazione di Pechino grazie alla conoscenza della lingua, delle usanze e delle abitudini locali, all’uso dei legami di parentela e di comunità, rafforzati da generose bustarelle e tangenti concesse ai burocrati nazionali e locali del Pcc, che in cambio riservavano loro un trattamento preferenziale di cui raramente godevano gli occidentali.
Anche se negli anni ’90 e 2000 i capitali occidentali affluiranno massicci, non si può dire che il capitale occidentale abbia né iniziato, né avuto mai la guida del processo di restaurazione capitalista in Cina.
Due elementi hanno sostenuto la crescita cinese: il controllo centrale del partito-Stato che ha prevenuto la crescita di una borghesia al suo esterno e l’ha coltivata al suo interno; il potere indiscusso esercitato da una burocrazia, ormai pienamente borghese (per quanto si dichiari comunista), composta al tempo stesso da dirigenti politici, manager ed amministratori.
È vero che gli investimenti occidentali hanno giocato un ruolo molto importante nel promuovere l’esplosione delle esportazioni cinesi, ma tale esplosione rappresenta solo un episodio tardivo dell’ascesa economica di quel paese.
Il capitale straniero (ed americano in particolare) ha avuto bisogno della Cina più di quanto la Cina abbia mai avuto bisogno del capitale straniero, in particolare per finanziare il gigantesco debito federale dell’amministrazione a stelle e strisce e ammortizzare gli effetti devastanti delle crisi economiche di questi anni.
La Cina obiettivamente minaccia l’egemonia Usa sul globo che è evidentemente entrata in crisi.
Questo è alla base delle tensioni esistenti tra i due paesi che esplodono con più forza sotto l’amministrazione Trump, ma che già con Obama avevano visto un notevole approfondimento.
La crisi mondiale e la via della seta
La proprietà di reti e infrastrutture cedute in cambio di finanziamento del debito di diverse nazioni (si pensi al porto del Pireo in Grecia, ormai di proprietà cinese) può cambiare gli equilibri economici consegnando a Pechino il monopolio mondiale dei traffici marittimi, stradali e ferroviari.
Solo in Africa, la Cina pensa di investire 60 miliardi di dollari per controllare le infrastrutture del continente.
Naturalmente, in un regime capitalista la politica dei prestiti per costruire infrastrutture, si traduce in una “trappola del debito”, con la chiara intenzione cinese di espandere la propria influenza ben oltre l’Indo-Pacifico.
Il tentativo è quello di esportare non solo i capitali ma anche il modello di sviluppo cinese. E non si tratta come negli anni ’90 di esportazione di prodotti di bassa qualità, la Cina oggi ha a disposizione conoscenze e un know how avanzato, di altissima qualità e composizione organica del capitale.
Nel 2017 Pechino ha dimostrato che la Belt and Road Initiative (Bri, o nuova via della seta) non è solo un progetto infrastrutturale, ma il prisma con cui osservare i piani della classe dominante cinese, proiettata verso l’estero e intimamente connessa alle questioni economiche e politiche interne.
L’inserimento della Bri nello statuto del Partito comunista cinese (Pcc) durante il XIX Congresso nazionale ha rimarcato la sua rilevanza nel lungo periodo per il “sogno cinese”, ovvero il ritorno della Cina a rango di potenza mondiale entro il 2049, nel centesimo anniversario della rivoluzione. La Bri ha contribuito a “questo risorgimento” riducendo in qualche misura la sovraccapacità industriale di Pechino, alimentando la crescita di alcune aree interne alla Repubblica popolare (vedi la municipalità di Chongqing o l’instabile Xinjiang), gli investimenti in uscita, le acquisizioni di know how straniero e l’aumento del commercio.
Eppure gli ostacoli e le contraddizioni sono molte lungo le nuove vie della seta. Usa, Giappone, India e Germania considerano la Bri uno strumento con cui la Cina potrebbe penetrare in settori d’interesse strategico. Alcuni progetti hanno subito rallentamenti o sono stati interrotti a causa dell’intervento diretto o indiretto di queste potenze.
Nel 2017, il commercio tra la Cina e i paesi che partecipano alla Bri ha superato i 780 miliardi di dollari. Dal 2013 a oggi, lungo le sue rotte gli investimenti del Dragone hanno superato i 50 miliardi di dollari e le imprese cinesi hanno contribuito alla creazione di 75 zone economiche e commerciali in 24 paesi. Le acquisizioni cinesi nel settore della logistica sono più che raddoppiate rispetto allo scorso anno, passando da 12,9 miliardi di dollari a 32,2, riporta il Financial Times. Le imprese statali (in fase di riforma) hanno trainato gli investimenti lungo le nuove vie della seta, mentre le operazioni di quelle private sono state circoscritte solo ad alcuni settori, per evitare fughe di capitali e manovre “irrazionali”.
Ne hanno risentito grandi aziende come Wanda, il gruppo assicurativo Anbang, il fondo d’investimento Fosun, Hna Group, e Suning, nuova proprietaria dell’Inter.
Allo stesso tempo, Pechino è stata costretta ad adottare misure per aprire il proprio mercato. Primo, ha annunciato l’innalzamento delle quote azionarie estere in banche (non solo commerciali), fondi d’investimento e compagnie assicurative dal 49 al 51%. Secondo, ha ridotto – per ora simbolicamente – i dazi alle importazioni su alcuni prodotti. È probabile che nel 2018 la Cina adotti altri provvedimenti simili, ma non si può parlare di liberalizzazione: il controllo dell’economia è ancora saldamente nelle mani del Pcc.
Solo nel 2017, i treni merci hanno percorso 3.270 volte la rotta tra Cina ed Europa, più della metà dei 6.235 condotti dal 2011 a oggi. Si stima che nel 2018 le tratte saranno 4mila.
Nel 2017 si sono gettate le basi per lo sviluppo di due nuove rotte nella cornice della Bri. La prima è quella artica, che un giorno potrebbe far risparmiare tempo e denaro nel trasporto merci tra Cina ed Europa rispetto a quella passante per l’Oceano Indiano e il canale di Suez. La “via della seta sul ghiaccio” è stata menzionata da Pechino in più occasioni e la rompighiaccio Xuelong ha compiuto la prima circumnavigazione cinese dell’Artico nel settembre 2017. Tra gli obiettivi cinesi vi è la costruzione di 10.500 chilometri di fibra ottica per collegare entro il 2020 i paesi dell’Europa centrale ed orientale coinvolgendo Finlandia, Norvegia, Russia e Giappone.
La seconda nuova via è quella digitale. L’e-commerce cinese è un settore dalle grandi prospettive (gli utenti di internet nella Repubblica popolare sono 751 milioni) cui anche le grandi multinazionali straniere sono fortemente interessate, come confermato dalla World Internet Conference svoltasi a Wuzhen a metà dicembre. In barba alle difficoltà legate alla censura dell’internet cinese, hanno partecipato all’evento colossi come Apple, Facebook e Google.
L’apertura della base militare cinese a Gibuti – la prima dei cinesi fuori dai confini nazionali – e le successive esercitazioni militari hanno evidenziato i risvolti securitari delle nuove vie della seta. La struttura svolge funzione di supporto logistico alle operazioni antipirateria nello stretto di Bab el-Mandeb. Il piccolo paese posizionato strategicamente sul Corno d’Africa è parte integrante della rotta marittima delle nuove vie della seta, grazie alla ferrovia lunga 752 chilometri che collega la capitale del paese ad Addis Abeba in Etiopia e al porto multiuso di Doraleh costruito dalla Cina e inaugurato
lo scorso maggio.
È altamente probabile che nei prossimi anni la Repubblica popolare accresca la propria presenza militare all’estero per proteggere i flussi commerciali, gli investimenti e i connazionali lungo la Bri. Specialmente in regioni instabili come Africa, Asia Centrale e Medio Oriente. Ciò accrescerà inevitabilmente il suo peso militare sul piano internazionale e le tensioni con le potenze antagoniste, a cominciare dagli Stati Uniti.
Coalizione anti-cinese
Usa, Giappone e India percepiscono le conseguenze politiche ed economiche delle nuove vie della seta e si stanno attrezzando per arginare le aspirazioni cinesi. Nel novembre del 2017, Donald Trump ha condotto un tour asiatico (con tappa anche a Pechino) e rilanciato il quadrilatero con Tokyo, Delhi e Canberra (il cosiddetto quad) per rafforzare i rapporti militari nel quadrante “Indo-Pacifico” e contrastare l’ascesa marittima della Cina.
Allo stesso tempo, ci sono varie multinazionali americane e giapponesi che vedono nella nuova via della seta, la possibilità di fare affari. L’azienda Usa General Electric ha firmato un accordo con il Silk Road Fund (creato da Pechino per finanziare la Bri) per sviluppare una piattaforma d’investimenti congiunta in infrastrutture energetiche. Mentre il Giappone ha annunciato che finanzierà progetti di partnership tra le sue aziende private e quelle cinesi. Partecipare, sia pure indirettamente, all’iniziativa può permettere a Washington e Tokyo di beneficiarne. Ma anche di provare a disinnescarla. Del resto, l’assenza di un progetto commerciale regionale made in Usa espone l’egemonia a stelle e strisce alla strategia di Pechino. Proveranno a distruggere quello che non sono più in grado di costruire.
L’India è stata la più dura oppositrice della Bri e le sue preoccupazioni sono state alla radice del faccia a faccia tra le sue truppe e quelle cinesi avvenuto nell’estate del 2017 nell’area del Doklam, contesa tra Repubblica popolare e Bhutan.
Delhi è preoccupata dalle attività di Pechino in Asia meridionale. Dopo molte resistenze, lo Sri Lanka, paese nella sfera d’influenza indiana, ha concesso alla Cina il controllo per 99 anni del porto di Hambantota. Inoltre, l’India non vede di buon occhio lo sviluppo del corridoio economico Cina-Pakistan, il cui sviluppo non è agevole. Pechino e Islamabad hanno dovuto irrobustire la presenza militare attorno al porto di Gwadar, terminale marittimo del progetto, a causa della presenza dei ribelli baluci.
I due governi stanno anche discutendo con Kabul l’estensione del corridoio all’Afghanistan. Questa triangolazione è utile alla Cina nell’ambito della lotta al terrorismo islamico, che minaccia la Bri e la sicurezza nazionale cinese. Il pugno di ferro di Pechino ha impedito quest’anno rilevanti attentati terroristici nel Xinjiang, dove abita la minoranza turcofona e musulmana degli uiguri. Tuttavia, il governo cinese è preoccupato dal possibile ritorno di jihadisti appartenenti a questa etnia dalla Siria e dall’Iraq.
Negli ultimi mesi sono cresciuti inoltre i timori riguardo una possibile penetrazione cinese nei settori d’interesse strategico dei paesi europei. L’Ue intende imporre limiti agli investimenti provenienti da paesi terzi e un nuovo metodo di calcolo dei dazi anti-dumping sulle importazioni. Ciò ha contribuito ad alimentare la tensione con Pechino, che considera queste misure un danno ai propri interessi.
Le perplessità continentali si sono accentuate nel novembre scorso durante il summit 16+1, svoltosi a Budapest tra Repubblica popolare e paesi dell’Europa centrorientale. La costruzione della linea ferroviaria tra porto del Pireo, Skopje, Belgrado e Budapest promossa dalla Cina ha subito dei rallentamenti. L’Ungheria non aveva infatti rispettato quanto previsto dall’Ue per assegnare l’appalto della propria sezione di rotta alla China Railway International Corporation e, in seguito a un’indagine della commissione Ue, ha dovuto indire una gara pubblica.
Visto che il progetto è finanziato dalla Repubblica popolare e che l’interferenza di aziende terze potrebbe danneggiare il rapporto tra Pechino e Budapest, diciamo che è altamente probabile che un’impresa cinese si aggiudichi comunque la realizzazione dell’opera.
La Cina ha davanti due soluzioni per superare le diffidenze dei paesi partner e schivare le pressioni di quelli antagonisti. La prima è aprire progressivamente il proprio mercato, processo che come abbiamo visto è già in atto. La Repubblica popolare del resto ha bisogno di stimolare i consumi e gli investimenti in entrata per dipendere in misura inferiore dalle esportazioni. Si stima che la Cina importerà 8mila miliardi di dollari di merci nei prossimi cinque anni. Inoltre, quest’anno gli investimenti di paesi della cornice Bri in Cina sono stati pari a 4,24 miliardi di dollari, il 34,4% in più rispetto allo scorso anno. I paesi stranieri possono quindi servirsi delle nuove vie della seta per potenziare le loro attività in Cina.
Che effetti politici tutto questo produrrà ha per noi un interesse straordinario.
Nuove esplosioni della lotta di classe?
Pensiamo di aver chiarito sufficientemente con dati e argomenti come le prospettive per la Cina sono quelle di un paese che da una parte sta sfidando la leadership americana sul piano internazionale ma che dall’altra sta accumulando enormi contraddizioni economiche, politiche e sociali al suo interno.
Pechino non ha affatto un sistema economico equilibrato. Negli ultimi tre anni ha prodotto una quantità impressionante di capitale fittizio ed un rapido indebitamento della sua economia. Si stima che per ogni cinque dollari di indebitamento si produca un solo dollaro di ricchezza.9
Mentre la classe dominante, che costituisce il 3% della popolazione cinese, ha accumulato ricchezze favolose (quasi esclusivamente figli, nipoti e pronipoti degli alti papaveri di partito), ci sono centinaia di milioni di poveri che affollano le periferie delle grandi metropoli cinesi.
Anche se in questi anni si sono applicate politiche di tipo keynesiano e aumenti salariali governati dall’alto (a cui vengono costrette anche le multinazionali straniere) questo non ha risolto le enormi contraddizioni cinesi. Secondo le parole di uno studioso cinese contemporaneo, “con le riforme sono peggiorati tutti i parametri, l’aria, l’acqua, la terra, la politica, l’educazione, i rapporti umani a eccezione del Pil.”10
La nuova generazione di operai ha svolto un ruolo protagonista, nel 2008 contro la nuova legge sul lavoro, nel 2010 con scioperi di massa che stanno continuando e si diffondono per ampiezza e durata. Ogni anno aumentano gli scioperi illegali. La nuova classe operaia cinese è molto più conflittuale rispetto al passato. Si stanno sviluppando una serie di organizzazioni autonome dai sindacati ufficiali, particolarmente nella zona del Guangdong, quella con la più avanzata coscienza di classe. A questo contribuisce non poco lo sfruttamento non solo nella manifattura ma anche nei servizi. Il lavoro assorbe tutti gli spazi della vita, l’aspettativa verso il futuro si riduce sempre più tra le giovani generazioni, l’acquisto di una casa è un miraggio nonostante ci siano decine di milioni di case vuote e sfitte.
Contraddizioni molto simili a quelle che hanno generato l’Autunno caldo in Italia (o il Maggio ’68 in Francia) ma su scala infinitamente più alta e senza i “margini di recupero” politici e sindacali che tutto sommato aveva l’Italia alla fine degli anni ’60. Ci riferiamo in particolare all’autorevolezza di cui godevano il Pci e la Cgil nella classe operaia, che contribuì non poco a deviare le mobilitazioni su un terreno riformista e non certo di rottura con il capitalismo.
D’altra parte la classe media cinese oltre ad essere piuttosto ristretta (meno del 10% della popolazione) è anche estremamente insoddisfatta e non rappresenta una base di consenso sufficiente a garantire stabilità al regime che sarà sempre più costretto ad usare il bastone, più della carota, anche perché i debiti che si impennano ad ogni livello rappresentano un limite al perseguimento di politiche riformiste e di concessioni alla classe operaia.
Nonostante i molteplici tentativi della burocrazia cinese di governare il capitalismo questo non ha impedito l’emersione dei peggiori aspetti dell’economia di mercato: speculazione finanziaria e immobiliare, diseguaglianza sociale e indebitamento progressivo ad ogni livello, con una classe operaia povera e sfruttata che si considera totalmente estranea al Partito comunista e ai sindacati ufficiali che non solo non vengono visti come propri ma sono considerati il nemico da abbattere.
Il paese è seduto su una bomba ad orologeria che non tarderà ad esplodere. Per cui non sappiamo dire se la Cina è più vicina a diventare la prima potenza mondiale o piuttosto il primo fattore di destabilizzazione del sistema capitalista su scala globale. Sarà la poderosa classe operaia cinese a rispondere a questa domanda.
Note
- http://en.ccg.org.cn/china-becomes-net-capital-exporter
- https.//www.ft.com/content/8e887bdc-04f3-11e7-ace0-1ce02ef0def9
- Si veda a tal proposito su falcemartello n. 4, L’imperialismo, un secolo dopo Lenin. https://www.marxismo.net/index.php/teoria-e-prassi/le-internazionali-operaie/308-l-imperialismo-un-secolo-dopo-lenin.
- Per una spiegazione approfondita dell’argomento rimandiamo i lettori al libro di Ted Grant, Russia, dalla rivoluzione alla controrivoluzione, AC Editoriale, Milano, 1999.
Sulla previsione di Trotskij rispetto alla possibilità di una controrivoluzione in Urss si veda La rivoluzione tradita, AC Editoriale, Milano, 2003. - https://www.forbes.com/china-billionaires/list
- https://www.tandfonline.com
- http://theconversation.com/chinas-private-companies-are-unjustly-labeled-as-communistparty-plants-73834
- Si veda a tal proposito: Cina, nuovo crocevia della crisi? (C. Bellotti, falcemartello n. 3, https://www.marxismo.net/index.php/la-nuova-epoca/138-cina-nuovo-crocevia-della-crisi) e Nuove tempeste sull’economia mondiale (A. Giardiello, Rivoluzione n. 33, pp. 6-7, http://www.rivoluzione.red/wp-content/uploads/2017/09/RIV_33x_sito_web.pdf).
- Citazione tratta da Per una definizione del regime cinese di Giorgio Casacchia e Diego Gullotta, https//www.retedeicomunisti.org/index.php/interventi/2094
