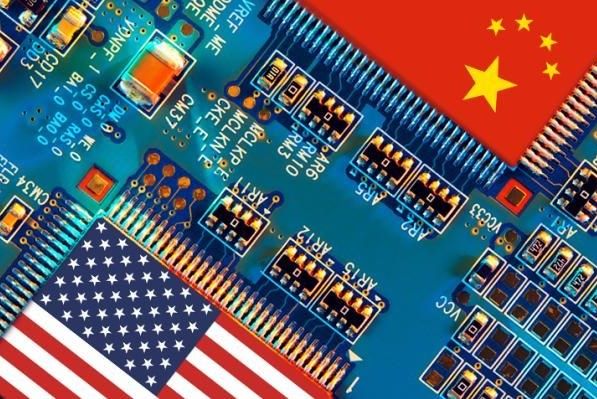
Lo scontro USA-Cina e i nuovi rapporti internazionali
24 Gennaio 2023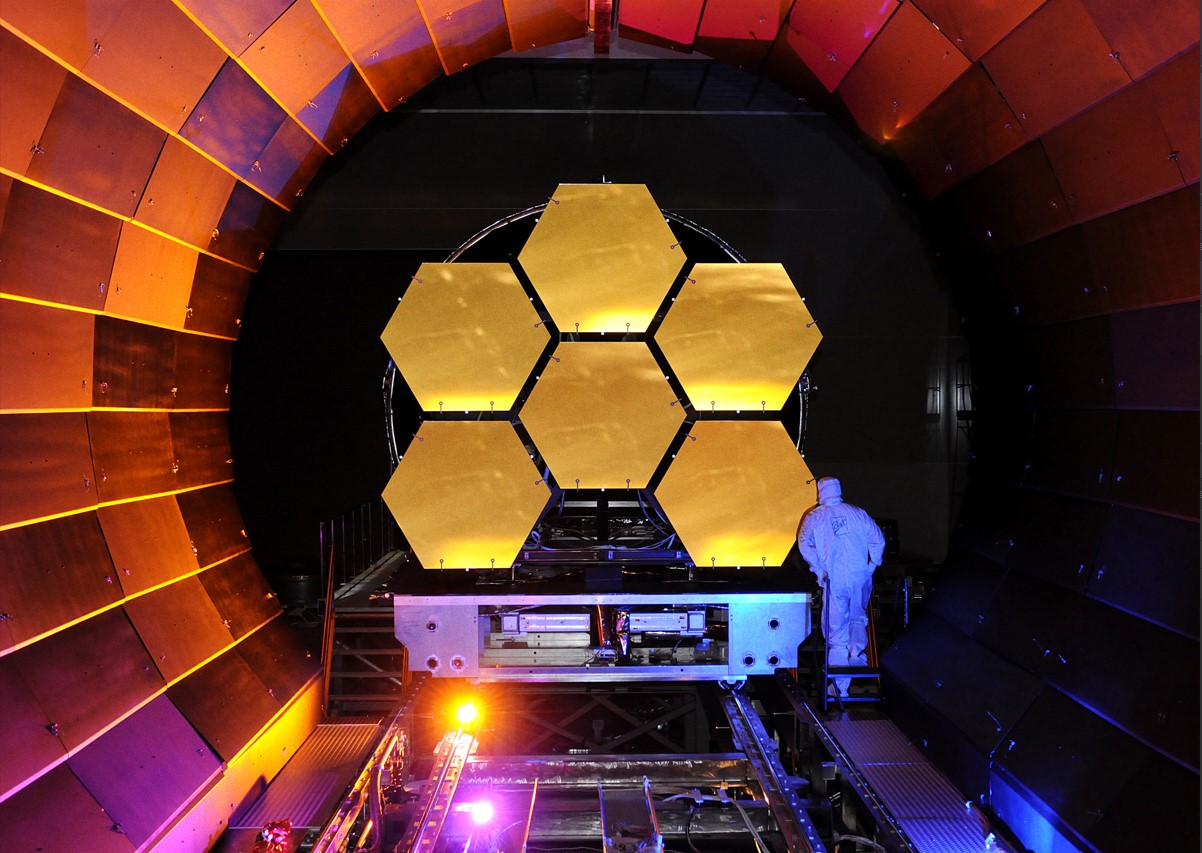
Il telescopio James Webb: un occhio su un universo infinito nel tempo e nello spazio
25 Gennaio 2023di Claudio Bellotti
La guerra in Ucraina ha messo bruscamente in luce una nuova realtà dei rapporti internazionali anche sul piano militare. Le basi economiche di questo mutamento sono trattate nel precedente articolo di questa rivista.
Il conflitto in corso non ha nulla a che vedere con le guerre condotte negli ultimi trent’anni, a partire dal primo attacco degli USA all’Iraq (1991). Quella guerra e le successive furono infatti caratterizzate dall’estrema asimmetria delle forze in campo. Gli USA e i loro alleati e vassalli hanno bombardato la Jugoslavia (1995 e 1999), invaso l’Afghanistan (2001), nuovamente l’Iraq (2003), sono intervenuti in Libia (2011) e Siria (dal 2012 in avanti) solo per citare gli avvenimenti più significativi. Alcuni di questi scontri hanno visto l’imperialismo USA inviare le proprie truppe in massa, in altri casi si sono basati su milizie locali sostenute da bombardamenti, rifornimenti, truppe speciali e “consiglieri”. In tutti questi casi, lo squilibrio delle forze militari era evidente, così come quello politico. Ad essere messi nel mirino erano Stati isolati, indeboliti e non in condizioni di resistere in una guerra convenzionale.
Non per questo le cose andarono lisce per gli USA, che hanno dovuto ritirarsi nel modo più umiliante dall’Afghanistan, dopo avere occupato e devastato il paese per vent’anni. Anche in Medio Oriente, nonostante l’occupazione dell’Iraq, il controllo di Washington si è tutt’altro che rafforzato.
La natura di queste guerre discendeva da un quadro dei rapporti di forza che vedeva gli USA come unica superpotenza, il poliziotto del mondo che interveniva nella remota periferia per richiamare all’ordine qualche riottoso. Non a caso vennero coniate espressioni quali “operazione di polizia internazionale” o “Stati canaglia” e la propaganda si beava nel descrivere immaginarie guerre chirurgiche, bombe intelligenti, guerre limitate, controllate, lontane dalla vita della popolazione dei paesi imperialisti.
Una prima svolta è avvenuta nel 2012 con l’intervento della Russia in Siria. Per la prima volta dopo decenni, l’imperialismo USA si trovava di fronte, se non una forza pari, una potenza militare importante. Lo scontro tuttavia fu per interposta persona: mai le armi russe e americane si trovarono direttamente a scontrarsi e alla fine gli USA dovettero sostanzialmente abbandonare il campo, dopo avere tentato di utilizzare le milizie fondamentaliste dell’Isis in un primo momento, e dopo un accordo con le milizie curde che però era puramente strumentale e venne cinicamente lasciato cadere. Dal conflitto è emersa una Siria devastata e controllata (non senza attriti) dalla Russia e dalla Turchia, mentre l’Iraq, diviso e indebolito, è sotto una forte influenza iraniana.
La sconfitta della politica USA in Siria (e in Libia), ribadita in modo ancora più clamoroso dalla fuga disordinata dall’Afghanistan (2021) ha segnato la fine di un’intera fase dei rapporti internazionali. Il sogno della pax americana si è dissipato lasciando il posto a uno scenario denso di incognite e di pericoli, in cui le tensioni internazionali sono salite a un livello mai visto dopo il 1945.
Oggi per l’imperialismo americano non si tratta più di governare su un mondo nel quale il suo potere appariva sostanzialmente senza rivali. L’imperativo è come difendere questo potere, che ha mostrato di essere in declino e di potere essere sfidato.
È istruttivo leggere il testo della National Security Strategy, pubblicata nell’ottobre del 2022 dal presidente Biden: un documento ufficiale che sintetizza le linee guida della politica estera di Washington per gli anni a venire. (1)
Una volta depurato il testo degli orpelli propagandistici sulla democrazia, i diritti e la prosperità, emerge a chiare lettere la visione della classe dominante americana, che si sintetizza nei seguenti punti:
1) Siamo la potenza più forte ma questo predominio è messo in discussione dall’ascesa della Cina.
2) Vi sono due avversari: la Russia è un avversario immediato, ma di taglia minore, che va contenuto, isolato e respinto alimentando la divisione tra Russia e Unione Europea, che deve armarsi e spendere di più per rinchiuderla nel suo spazio.
3) La Cina è l’avversario strategico e l’indo-pacifico è il terreno principale di questo scontro. Con la Cina gli USA possono coesistere, ma solo a condizione di non perdere il primato militare e tecnologico e di limitare la sua espansione economica sul piano internazionale. In altre parole, gli USA ritengono che la pace con la Cina possa essere preservata solo se quest’ultima rimane in posizione subordinata.
4) Nel giro di un decennio si capirà se questi obiettivi possono essere ottenuti pacificamente (questa conclusione non è scritta a chiare lettere, ma è implicita in diversi passi del documento).
Riassumendo all’essenziale, la classe dominante USA ha preso pienamente coscienza della imprescindibile necessità di organizzarsi per una controffensiva: o reagire, o rassegnarsi a un inesorabile declino.
È impossibile capire la guerra in Ucraina al di fuori di questa analisi generale.
Radici e sviluppo del conflitto in Ucraina
Già nel 2014, poco dopo la rivolta reazionaria di Euromajdan che spinse al potere a Kiev la destra nazionalista e l’estrema destra, indicavamo chiaramente quali fossero le connessioni internazionali di questo scontro, e in particolare il ruolo degli USA.
“Il ruolo degli USA nel conflitto ucraino può essere compreso solo a partire dalla posizione mondiale dell’imperialismo americano. Gli USA non hanno interessi economici chiave in Ucraina, né di altro genere. Tuttavia fin dal principio del movimento di Euromajdan il Dipartimento di Stato, la Cia e l’amministrazione di Washington hanno gettato tutto il loro peso contribuendo in misura importante a esacerbare il conflitto, in primo luogo dando ai settori più oltranzisti a Kiev la certezza di essere spalleggiati da un alleato potente.
Per oltre vent’anni gli USA hanno umiliato e provocato la Russia promuovendo l’espansione della NATO nell’Europa centro-orientale, fino a includere tutti i paesi che in precedenza erano stati parte del Patto di Varsavia nonché alcune delle ex repubbliche sovietiche. L’ultima espansione della NATO (2004) e la tesi di Rumsfeld sulla “Nuova Europa”, alleata degli USA, contrapposta alla “Vecchia Europa” (ossia a Francia e Germania, riluttanti all’epoca a unirsi all’avventura USA in Iraq) dimostravano come tale politica aveva due obiettivi: intimidire la Russia e mantenere le potenze europee nella condizione di gregari degli USA.
Si aggiunga che nonostante il grande arsenale atomico tutt’ora in mano alla Russia, la possibilità di dispiegare armi antimissile a ridosso dei suoi confini fa prefigurare la possibilità di neutralizzare in gran parte tale arsenale, restituendo agli USA il potere di iniziativa nell’uso dell’arma atomica, un potere che avevano perso a partire dai primi anni ’50 del secolo scorso. Al di là della effettiva praticabilità di questi progetti è indubbio che questa minaccia giochi un ruolo centrale nello spiegare la reazione di Putin sia in Georgia che ora in Ucraina.
Ma l’ingerenza USA in Ucraina ha anche un altro obiettivo, seppure meno palese, ed è la Germania e l’Unione Europea. Rompere il legame fra UE e Russia significa colpire le basi del capitalismo tedesco, le zone dove ha maggiormente allargato la propria sfera di influenza esportando merci e fabbriche, nonché colpirla nel punto debole degli approvvigionamenti energetici (particolarmente critico per paesi come Germania e Italia, meno per la Francia).
La Merkel ha tentato in tutti questi mesi di opporre una resistenza passiva alla pressione di Washington, provando a prendere tempo e a ridurre l’ampiezza delle sanzioni imposte alla Russia, a cercare una mediazione che salvaguardasse i propri interessi e i rapporti con la Russia. Tuttavia alla fine si è dovuta ogni volta adeguare alla pressione del più forte “alleato”, seguendolo sulla strada dell’escalation, sia pure con riluttanza. La realtà è che di fronte a un serio scontro fra Russia e USA non esiste lo spazio per una politica indipendente da parte della Germania 1) per la sua debolezza militare 2) per le divisioni nell’Unione Europea.
In Siria l’imperialismo USA si è scontrato con una opposizione frontale della Russia e della Cina, quale da decenni non aveva più incontrato. Ne è derivato uno scacco umiliante per Obama (e per Cameron), costretto a fare marcia indietro e a coprirsi di ridicolo. Una seconda e più grave sconfitta diplomatica in Ucraina sarebbe un colpo durissimo non solo agli interessi, ma anche al prestigio di Washington. E il prestigio (o se si preferisce, la credibilità delle proprie minacce) è parte non secondaria di qualsiasi politica estera.
Un vero accordo sarebbe possibile solo col pieno coinvolgimento di USA e Russia, ma ad oggi questo potrebbe materializzarsi solo con una resa di fatto di Putin, che non appare affatto disposto a ripercorrere i passi di Eltsin negli anni ’90.
Ne deriva uno sbilanciamento senza precedenti della politica USA, che spiega perché nonostante molti interessi teoricamente dovrebbero convergere a favore di un qualche compromesso (che sarebbe sempre a spese degli interessi del popolo ucraino), questo accordo non si materializzi e, al contrario, la crisi si avvolga in un circolo vizioso.” (Tesi sull’Ucraina, congresso mondiale della Tendenza Marxista Internazionale, luglio 2014). (2)
L’attuale guerra non era stata necessariamente pianificata in questa forma, anche se gli USA hanno investito cifre consistenti negli scorsi anni per armare e addestrare l’esercito ucraino. L’idea generale era di tenere una spina nel fianco della Russia aizzando l’Ucraina a riprendere il conflitto nel Donbass, trascinando la Russia in un pantano, e tenendo sospesa la minaccia di una futura possibile adesione dell’Ucraina alla NATO. Di fatto la prospettiva della futura entrata dell’Ucraina e della Georgia nella NATO era stata già esplicitamente assunta nel vertice NATO di Bucarest nel 2008.
Nel 2008 con una invasione-lampo, la Russia fermò il tentativo della Georgia di avvicinarsi alla NATO. Un precedente che potrebbe aver portato Putin a un grave errore di calcolo riguardo l’Ucraina.
La decisione di Putin di tagliare il nodo ucraino lanciando l’invasione su vasta scala il 24 febbraio 2022 ha cambiato questo scenario ponendo il conflitto su un terreno assai più vasto.
Né a Mosca, né a Washington ci si aspettava un conflitto di queste proporzioni e durata. Del resto, se per la classe dominante fosse sempre possibile calcolare l’esito delle proprie azioni e dei rapporti di forza, le guerre non scoppierebbero. La resistenza dell’esercito ucraino è stata l’elemento, politico e militare, che ha generato una nuova situazione. Seppure il conflitto aveva inizialmente come posta in gioco gli stessi territori contesi dal 2015, oggi è uscito definitivamente dalla sua dimensione circoscritta ed è diventato lo snodo cruciale dei rapporti mondiali, perlomeno in questa fase. Dopo il 24 febbraio l’oggetto dello scontro non erano più le sorti di un territorio limitato (il Donbass), bensì di piegare l’Ucraina separandola dalla sua crescente integrazione nella NATO.
Per questo motivo la prospettiva di un compromesso rimane chiusa. Nella fase iniziale più favorevole alla Russia, un accordo sarebbe stato impossibile per Zelensky, che avrebbe dovuto di fatto capitolare, rischiando peraltro di essere rovesciato (o peggio) dai fascisti e dai settori nazionalisti più oltranzisti.
Nelle ultime settimane da più parti sulla stampa occidentale si tenta di suggerire che i recenti successi ucraini nel contenere e in parte nel respingere l’invasione renderebbero più plausibile una trattativa. Si è detto che dopo la ritirata russa presso Kharkiv questo sarebbe stato possibile, e con più forza se ne parla ora: “Prendere Kherson e poi trattare”, era l’auspicio nelle capitali occidentali, inclusa Washington.
Ma il fatto che una cosa sia “logica” non significa che si realizzerà. L’esperienza di questi mesi dimostra che quando una delle due parti ha acquistato una posizione di relativo vantaggio, questo non ha aperto la strada alla trattativa, ma a un inasprimento del conflitto.
Oggi la Russia è in difficoltà, non tanto sul terreno strettamente militare, ma nella prospettiva e nel morale. Tuttavia continua ad occupare circa il 15 per cento del territorio ucraino, dopo avere per giunta dichiarato di annetterne ulteriori parti che al momento non controlla, compresa la stessa Kherson. Per Mosca una trattativa su questi territori (che comunque non comprenderebbe la Crimea) sarebbe plausibile solo in cambio di una capitolazione politica dell’Ucraina, ossia una esplicita rinuncia a integrarsi nel blocco occidentale, un controllo sul suo armamento e altre analoghe garanzie. Una ipotesi inaccettabile per Zelensky, che oggi si dipinge come un vincitore e che ha quindi rapidamente negato la possibilità di sedersi a un tavolo nonostante i “caldi” inviti ricevuti dai suoi protettori di Washington.
Per la Russia si tratta oggi di prendere tempo, completare l’inserimento delle truppe mobilitate (ed eventualmente mobilitarne di nuove), rifornirsi e preparare una nuova offensiva, continuando nel frattempo a logorare tanto l’esercito ucraino come la popolazione civile nelle retrovie.
Al di là dei trionfalismi, l’Ucraina è duramente provata sia dalle perdite di militari (che in proporzione sono nettamente più pesanti di quelle russe), sia dalle devastazioni subìte. Il sostegno occidentale le garantisce di non doversi piegare, ma è tutt’altra cosa ipotizzare che possa infliggere all’esercito russo una sconfitta decisiva in campo aperto. Si profila quindi non il negoziato, ma un incancrenimento del conflitto, dal quale nessuno dei protagonisti può facilmente districarsi.
Gli USA non vogliono essere trascinati in un conflitto su vasta scala con la Russia e per questo, pur inviando in Ucraina quantitativi senza precedenti di armamenti, hanno sin qui rifiutato a Zelensky quegli armamenti offensivi che potrebbero portare a uno scontro a tutto campo con la Russia.
In effetti lo scopo iniziale degli USA non era distruggere la Russia ma indebolirla e, se possibile, provocare la caduta di Putin. Il problema è che in una guerra non è possibile determinare unilateralmente i propri obiettivi e “dosare” a piacimento il livello di impegno. Una volta dichiarato il sostegno a Kiev “fintanto che sarà necessario”, gli USA non possono ora tirarsi indietro facilmente.
Se anche il massacro di soldati, le distruzioni e i costi del conflitto portassero ad un certo punto a un armistizio, questo non sarebbe risolutivo. Sarebbe una ripetizione allargata degli accordi di Minsk del 2015, sottoscritti dall’Ucraina senza alcuna intenzione di rispettarli.
Non esiste una seria possibilità che l’esercito ucraino respinga i russi militarmente fuori dai propri confini. Solo un impegno molto maggiore da parte della NATO e degli USA potrebbe forse portare a un simile ribaltamento dei rapporti di forza sul campo, ma gli USA per ora resistono a fornire i mezzi nella quantità e qualità necessarie, per timore di trovarsi invischiati in uno scontro diretto tra NATO e Russia. Per quanto l’esercito russo sia ora sulla difensiva, sloggiarlo dai territori occupati è un’impresa superiore alle forze dell’Ucraina, e in caso di nuovi e seri arretramenti Mosca non esiterebbe a gettare altre forze sul campo.
D’altra parte, se si profilasse il pericolo di una netta sconfitta dell’Ucraina, questo spingerebbe a un’ulteriore intervento occidentale, forse anche diretto. Per quanto agli USA l’Ucraina interessi solo come pedina da usare contro la Russia, non possono abbandonarla facilmente dopo essersi assunti di fronte al mondo la parte di paladini e protettori di Kiev. Non per motivi “morali”, ma perché sarebbe una dichiarazione di sconfitta di fronte al mondo intero, che incrinerebbe in modo irrimediabile il potere dell’imperialismo nordamericano. L’ipotesi più realistica in caso di vittoria russa, sarebbe la sopravvivenza di un’Ucraina ridimensionata territorialmente, dipendente a tempo indeterminato dai finanziamenti occidentali, ma armata fino ai denti e controllata con pugno di ferro dalle forze nazionaliste in cerca dell’occasione per una rivincita.
Per giunta, a fronte della relativa cautela di Washington, esiste nella NATO un fronte oltranzista che è attivamente impegnato a cercare un casus belli per arrivare a uno scontro diretto fra NATO e Russia. Questo fronte comprende innanzitutto la Polonia e la Lituania, con il benevolo sostegno di Londra. Solo così si possono interpretare episodi come il sabotaggio del gasdotto Nord Stream, le incursioni in pieno territorio russo provenienti, secondo ogni probabilità, dal territorio lituano, e soprattutto il tentativo, tra giugno e luglio, di applicare un blocco terrestre da parte della Lituania contro l’enclave russa di Kaliningrad.
Quest’ultima mossa è stata poi disinnescata dalla Commissione europea, nella consapevolezza che avrebbe potuto aprire uno nuovo scontro dalle conseguenze imprevedibili, forse anche sul terreno militare.
Allo stesso modo, Biden si è affrettato a disinnescare la minaccia di escalation dopo che il 16 novembre due missili ucraini sono caduti oltre il confine polacco, facendo due vittime.
Con la richiesta di adesione alla NATO della Svezia e della Finlandia, che ha anche annunciato la costruzione di un muro al confine con la Russia, la NATO arriva a bloccare completamente la Russia verso occidente. Seppure la presenza militare in Europa orientale è tutt’ora relativamente ridotta (20-40.000 uomini), non può sfuggire la misura dello spostamento degli equilibri.
Basti ricordare che negli anni ’60 del secolo scorso, quando gli analisti cercavano di valutare la prospettiva di uno scontro convenzionale (non nucleare) tra la NATO e il Patto di Varsavia, l’ipotesi più accreditata era che le truppe del Patto di Varsavia sarebbero arrivate sulla Manica nel giro di un paio di settimane. Allora il punto di partenza di una guerra convenzionale era la Cortina di ferro, ossia la linea che divideva in due la Germania, il confine austriaco e il confine orientale italiano. Oggi la “linea di partenza” di un ipotetico scontro diretto si è spostata verso est di centinaia di chilometri e tutti gli ex paesi componenti il Patto di Varsavia sono parte della NATO, così come le ex repubbliche sovietiche Estonia, Lettonia e Lituania.
Recentemente gli USA hanno inviato un’unità di élite, la 101° divisione aviotrasportata, in Romania. Non c’è dubbio che questa mossa vada interpretata come la premessa di un possibile nuovo conflitto, questa volta in Moldavia, per sottrarre la regione separatista della Transnistria dall’influenza di Mosca, se la situazione lo permettesse. Allo stesso modo Washington ha ribadito il suo sostegno (per ora platonico) alle “aspirazioni” della Georgia di integrarsi nel blocco occidentale.
Le ricadute del conflitto e la divisione in blocchi
La polarizzazione dello scontro in Ucraina ha le sue ricadute vicine e lontane. Nei Balcani si riaccendono le tensioni tra serbi e albanesi nel Kosovo mentre in Bosnia il rilancio della richiesta di adesione alla NATO potrebbe portare a nuovi conflitti interni, con il possibile intervento della Croazia e della Serbia e il rischio di una ulteriore frammentazione.
Ancora più complessa la situazione in Medio Oriente. Per molti mesi i principali paesi hanno scelto di non schierarsi nel conflitto russo-ucraino. Israele ne è l’esempio più chiaro, ma anche l’Arabia Saudita ha tenuto le distanze da Biden negandosi alle richieste di aumentare la produzione petrolifera per sopperire alle carenze causate dalle sanzioni contro la Russia. La Turchia, dal canto suo, pur inviando armi all’Ucraina e continuando la sua politica di espansione verso il Caucaso e l’Asia centrale, ha scelto fin da principio la posizione di mediatore, della quale profitta anche nella maggiore mano libera di cui ora può godere in Siria.
Ma questo fragile equilibrio potrebbe non reggere se il conflitto si radicalizzerà ulteriormente. L’Iran, già sotto una forte pressione dagli USA, ha un rapporto fondamentale con la Russia e non vuole vederla estromessa dal Mar Nero e allontanata dalla sua influenza in Siria. Pertanto Teheran ha iniziato a inviare armi alla Russia, e continuerà a farlo. Questo schieramento potrebbe rompere l’equilibrio tra Iran e Arabia Saudita, portando a uno scontro diretto o indiretto, come già avvenuto in Yemen, così come potrebbe portare a una rottura degli attuali equilibri in Siria e a un riaccendersi del conflitto che rischierebbe di coinvolgere anche Israele.
La guerra in Ucraina oggi è al centro delle tensioni internazionali, ma la contraddizione fondamentale della nostra epoca è quella tra USA e Cina. Tuttavia i due conflitti, quello USA-Russia e quello USA-Cina sono strettamente legati. Le divisioni nella classe dominante americana al riguardo si concentrano sulla scelta delle priorità, non certo sull’obiettivo generale. Un settore della borghesia nordamericana, di cui Trump fa parte ma che comprende anche altre correnti, ritiene eccessivo l’impegno per l’Ucraina in quello che considerano uno scenario secondario rispetto alla necessità principale di fronteggiare la Cina, mentre un’altra parte, a partire dall’amministrazione in carica, ha dato priorità, almeno nel breve termine, all’impegno in Europa. Si ripropone una divisione che ricalca quella degli anni immediatamente precedenti la Seconda guerra mondiale, quando la destra isolazionista predicava che gli USA dovessero tenersi lontani dai conflitti del continente europeo e concentrarsi sulla lotta per il controllo dell’Oceano Pacifico. Quando poi la guerra scoppiò, la divisione si ripropose sulle priorità strategiche, con il presidente democratico Roosevelt che alla fine fece pendere la bilancia in favore dell’impegno prioritario in Europa.
Ma in nessun caso queste diverse opinioni mettono in dubbio l’obiettivo finale di rilanciare l’egemonia USA nel mondo, con le buone o con le cattive.
Il citato documento dell’Amministrazione Biden chiarisce bene la natura di questo scontro. Leggiamo al capitolo sulle “priorità globali”, sotto il titolo “Bloccare la Russia, vincere la competizione con la Cina” cosa scrivono alla Casa Bianca: “La Repubblica popolare cinese è l’unico concorrente che abbia sia la volontà di ridisegnare l’ordine internazionale che, in misura crescente, la forza economica, diplomatica, militare e tecnologica per farlo. Pechino ambisce a creare una sfera d’influenza rafforzata nell’Indo-Pacifico e a diventare la potenza guida del mondo. Usa la sua capacità tecnologica e la sua crescente influenza sulle istituzioni internazionali per creare condizioni più favorevoli al suo modello autoritario e per plasmare le norme e le consuetudini della tecnologia globale in modo da privilegiare i propri interessi e valori.”
È interessante come il documento sottolinei che l’ascesa della Cina sia stata una conseguenza della fase di libero commercio e che quindi il protezionismo e l’intervento dello Stato a sostegno dell’economia siano essenziali per affrontare un nemico pericoloso.
Il testo delinea una prospettiva molto chiara: la coesistenza può essere pacifica solo se la Cina rimarrà subordinata, in posizione di svantaggio e se verrà contenuta l’espansione internazionale della sua economia (esportazioni e soprattutto investimenti esteri e relativa influenza politica in altre aree del mondo).
Questi gli strumenti da impiegare: rafforzare le “ferree” alleanze USA nel Pacifico con la relativa presenza militare; sottoporre la Cina a quello che di fatto sarebbe un embargo sulle alte tecnologie, attraverso il controllo dello Stato sulle esportazioni e gli investimenti: “Dobbiamo assicurarci che i nostri concorrenti strategici non possano sfruttare tecnologie, dati e conoscenze, per minare la sicurezza dell’America e dei suoi alleati. Stiamo pertanto modernizzando e rafforzando i nostri controlli sulle esportazioni e la sorveglianza sugli investimenti, nonché stiamo perseguendo nuovi approcci mirati come la sorveglianza sugli investimenti all’estero.”
Non sono solo progetti, se consideriamo i recenti provvedimenti come il chips act (50 miliardi di dollari per garantire la supremazia nei semiconduttori di ultima generazione) o il recente blocco di queste esportazioni verso la Cina, non solo da parte degli USA ma di qualsiasi impresa che utilizzi brevetti USA in questo settore.
Il documento è esplicito nel considerare come un tutt’uno gli aspetti economici e quelli militari. L’era della cooperazione è finita, tutte le catene di fornitura vanno rilette in base all’imperativo della sicurezza e gli alleati si devono “allineare”, o meglio devono essere messi in riga.
È importante sottolineare che il testo mette sotto critica due dei pilastri della fase della globalizzazione. È infatti esplicito nell’indicare l’ascesa della Cina come una delle conseguenze negative dell’apertura dei commerci: “Riconoscendo che dobbiamo andare oltre i tradizionali accordi di libero scambio, stiamo programmando nuovi accordi economici che approfondiscano il nostro impegno economico con i nostri soci, come l’IPEG (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity)”. In altre parole, è finita l’era del WTO e degli accordi globali, e siamo definitivamente entrati in quella dei blocchi commerciali contrapposti.
L’altro pilastro che viene abbattuto è quello della preminenza del privato e della ritirata dello Stato dall’economia. Per difendere il predominio USA, lo Stato deve intervenire attivamente: “Tuttavia, i mercati da soli non possono rispondere al rapido ritmo del cambiamento tecnologico, agli sconvolgimenti delle forniture globali, agli abusi anti-mercato della Repubblica popolare cinese e di altri soggetti, o all’aggravarsi della crisi climatica. L’investimento strategico pubblico è la colonna vertebrale di una forte base industriale e dell’innovazione nell’economia globale del XXI secolo.” Si richiamano poi i 280 miliardi di investimenti autorizzati dal Chips and Science Act.
Corollario politico-ideologico di questa profonda svolta, Washington rinuncia ufficialmente alla vecchia favola dell’“esportazione della democrazia”. I buoni sono i democratici, poi ci sono gli antidemocratici cattivi grandi (Cina e Russia), quelli piccoli (Corea del Nord, Iran, Cuba, Venezuela…) e infine numerosi non democratici che sono però da considerarsi buoni fintanto che accettino un ordine internazionale “basato sulle regole”, ossia obbediscano agli USA o almeno collaborino.
“Troppo spesso siamo finiti nell’automatismo di politiche centrate sull’intervento militare, sorrette da una fiducia irrealistica che la forza e il cambiamento di regime potessero offrire esiti sostenibili, mancando invece di tenere conto adeguatamente del rapporto costi benefici rispetto a priorità globali in alternativa fra loro, o le conseguenze inattese.”
Regime change è la formula stereotipata usata contro l’Iraq, e a seguire contro decine di altri paesi, per indicare il rovesciamento, con l’intervento militare o con la sovversione interna, dei regimi malvisti a Washington, e in questa frase contorta sono riassunti trent’anni infamie e di sanguinosi fallimenti della politica estera USA.
Ad ogni modo, oggi l’analisi “costi/benefici” sconsiglia agli USA di fare troppo gli schizzinosi nella scelta degli alleati. Non che in passato fosse differente, ma anche le forme hanno la loro importanza…
Un mondo multipolare?
Non sono pochi coloro che vedono nel conflitto ucraino un passaggio importante nella transizione da un mondo “unipolare” ad uno “multipolare”, nel quale dall’egemonia incontrollata degli USA si passerebbe a un sistema di rapporti tra diverse potenze o blocchi, garantendo un maggiore equilibrio e la nascita di nuove regole condivise, superando il potere arbitrario esercitato dall’imperialismo a stelle e strisce.
È questa la parola d’ordine di Pechino, di Mosca e di molti altri paesi, che comprensibilmente suscita una eco anche fra quei popoli che maggiormente hanno subìto in passato il dominio statunitense e che sperano che queste contrapposizioni fra grandi potenze possano creare uno spazio di maggiore autonomia e indipendenza per i paesi più deboli e sfruttati.
La realtà è assai diversa. Il “multipolarismo” altro non è che la costruzione di potenti blocchi in feroce competizione l’uno con l’altro ai fini di conquistare l’egemonia mondiale. In questa competizione l’imperialismo USA parte comunque avvantaggiato. Gode di una presenza militare senza pari nel mondo, di una spesa militare pari alla somma delle successive 10 maggiori potenze, di una rete di alleati e paesi vassalli imparagonabile a quella della Cina o della Russia.
Tuttavia, come esplicitamente si scrive nel testo citato, tutto questo non basta più ad intimidire il resto del mondo e a sottometterlo.
Da sempre la difesa dello statu quo è la consegna generale delle potenze dominanti, tanto più quando le basi del loro passato potere cominciano a venire meno. L’uso della forza è contemplato non per cambiare l’assetto, ma per difenderlo.
Il “multipolarismo” oggi è, invece, la parola d’ordine delle potenze che cercano di modificare l’assetto attuale (Cina e Russia in primo luogo, ma anche altre potenze di dimensione regionale come Turchia o India), mentre la “difesa delle regole” è la parola d’ordine di chi di queste regole è estensore e beneficiario, ossia degli USA.
Dopo avere raccontato per decenni che con il libero commercio e la libera circolazione dei capitali il mondo sarebbe avanzato verso la pace, il benessere e l’integrazione, oggi la classe dominante canta una canzone diversa: “autosufficienza” e “sicurezza”, ossia blocchi economici e riarmo, sarebbero la chiave per la pace. Dialetticamente, i decenni della globalizzazione sono sfociati nel proprio opposto.
Ma un mondo diviso in blocchi in concorrenza fra loro (e sotto il capitalismo non può che essere così) non sarebbe altro che un nuovo passo verso conflitti ancora più distruttivi di quelli attuali. È impossibile “congelare”, anche volendo, i rapporti di forza militari ed economici: un blocco cresce più rapidamente, uno più lentamente, la gara per influenzare le diverse aree del mondo continua incessantemente… Da nuovi squilibri nascono nuove pretese, le potenze in ascesa pretendono maggiore spazio, quelle in declino lottano per difendere il proprio. I paesi minori non possono altro che scegliere da quale padrone farsi dominare.
La conseguenza diretta della divisione del mondo in blocchi è una nuova corsa agli armamenti, dalla quale nessun paese potrà sottrarsi.
Seppure le spese militari mondiali hanno superato per la prima volta lo scorso anno la cifra di duemila miliardi di dollari, la tendenza sarà a una ulteriore esplosione. Per quanto riguarda le armi convenzionali, la guerra in Ucraina sta letteralmente svuotando gli arsenali e tutti i paesi si stanno ponendo il problema di incrementare massicciamente la produzione di munizioni, veicoli, missili, ecc., su una scala non vista da decenni. La Germania ha annunciato un piano di 100 miliardi di euro di nuove spese militari, il Giappone punta a raddoppiare il proprio bilancio militare, ecc. Ma oltre alle armi convenzionali si accelera sulla ricerca e l’investimento in tutte le direzioni.
Un articolo sulla rivista Foreign Policy (1 luglio) disegna la prospettiva di una nuova corsa al riarmo nucleare come elemento essenziale per gli USA se vogliono “contenere” Cina e Russia. (Foreign Policy, storica e autorevole rivista di politica estera, è oggi di proprietà del Washington Post, ossia del padrone di Amazon Jeff Bezos).
La stima è che la spesa militare USA, che oggi ammonta a 800 miliardi, pari a circa il 3,5 per cento del PIL, debba salire “ad almeno il 5 per cento per questo decennio e oltre”. Sarebbe un aumento del 40% circa, per un paese che già oggi spende in armi una somma pari a dieci successivi paesi nella classifica della spesa militare.
L’articolo traccia una ottimistica prospettiva secondo la quale con una corsa al riarmo anche nucleare, gli USA potrebbero piegare la Cina come il riarmo degli anni ’80 piegò l’Unione Sovietica, mettendola di fronte a una sfida troppo costosa e complessa per la sua economia.
“Alla fine potrebbero diventare possibili accordi trilaterali per limitare i missili a raggio intermedio, le forze nucleari strategiche o le applicazioni potenzialmente destabilizzanti dell’intelligenza artificiale e di altre nuove tecnologie, ma molto probabilmente ci sarà bisogno che gli Stati Uniti dimostrino dapprima che una corsa agli armamenti senza limiti alla fine lascerebbe i suoi rivali più poveri e più vulnerabili. (…)
Le competizioni militari ad alto rischio stanno già infuriando oggi e gli Stati Uniti hanno un disperato bisogno di dare loro una forma. Una corsa agli armamenti è inutile soltanto per chi la perde.”
Questo significa non soltanto una enorme e folle spesa militare (che naturalmente non esploderebbe solo negli USA, ma in tutti i paesi), ma anche la scelta dei paesi “alleati”, in Europa e in Asia, come terreno di scontro e avamposti all’occorrenza sacrificabili. Ecco un esempio: “Allo stesso modo, se Pechino vuole condurre una corsa missilistica a raggio intermedio, Washington può usare la sua rete di alleati per trasformare un attuale vantaggio cinese in uno svantaggio futuro. Dopotutto i missili convenzionali americani a raggio intermedio possono facilmente raggiungere la Cina continentale, mentre i missili cinesi a raggio intermedio non possono raggiungere gli Stati Uniti.”
Per lo stesso motivo il recente aggiornamento delle linee guida per le forze nucleari USA rimette in campo la modernizzazione delle atomiche “tattiche” destinate allo schieramento nei paesi NATO), compresa l’Italia, che già le ospita nelle basi di Ghedi e Aviano.
La fondatezza del paragone con la Guerra Fredda tra USA e URSS è come minimo da dimostrare. Allora, la prospettiva di una guerra nucleare era esclusa dal novero delle scelte logiche. Ogni uso dell’arma atomica avrebbe comportato una immediata risposta generale della parte avversa secondo la ben nota logica della “mutua distruzione assicurata”.
Ma l’“equilibrio del terrore”, come veniva chiamato, non discendeva semplicemente dalla natura distruttiva delle armi nucleari: era piuttosto una conseguenza di un rapporto di forza complessivo, scaturito dalla Seconda guerra mondiale e sancito dagli accordi di Yalta del 1945. La spartizione del mondo tra la sfera sovietica e quella americana non venne mai messa in discussione fino alla crisi terminale dell’URSS, nella seconda metà degli anni ’80. Fino ad allora i conflitti più sanguinosi come le guerre di Corea, del Vietnam, dell’Afghanistan, vennero sempre contenuti entro limiti precisi dalle due superpotenze, e le suggestioni dei “falchi” a stelle e strisce che periodicamente proponevano l’uso dell’atomica (per esempio durante la guerra di Corea) rimasero senza seguito.
La dottrina militare non determina la politica, bensì il contrario. E la dottrina militare della guerra fredda si basava sui princìpi del No first use e del sole purpose (ossia non dare l’avvio a un conflitto nucleare e considerare l’arma atomica al solo scopo di deterrenza o rappresaglia), precisamente in ragione dei rapporti di forza stabiliti nel 1945 come risultato militare e politico di un conflitto planetario.
Oggi la presidenza Biden non a caso abbandona questi criteri, come riporta la Repubblica il 29 ottobre 2022:
“Abbiamo condotto la revisione di un largo spettro di opzioni sulla politica di dichiarazioni – tra cui il No First Use e il Sole Purpose – e abbiamo concluso che questi approcci potrebbero comportare un livello di rischio inaccettabile alla luce della gamma di capacità non nucleari che vengono schierate e progettate dai nostri avversari, tali da infliggere danni strategici agli USA e ai nostri alleati”.
Prosegue lo stesso articolo:
“Nulla è più uguale a prima: non esiste più la routine dei manuali militari. Anzitutto, l’America deve fare i conti con due grandi potenze nemiche. La Cina resta l’avversario principale, perché continua a crescere aumentando e modernizzando la sua forza militare ma già ‘incrementa le azioni coercitive per ridisegnare la regione del Pacifico e il sistema internazionale per imporre le sue indicazioni autoritarie’. Ma se Pechino è il pericolo del futuro, il presente è dominato dall’aggressione russa all’Ucraina che ripropone la centralità dell’Europa, completamente dimenticata negli scorsi venti anni. Nel documento c’è la risposta a Putin: ‘Il Pentagono si concentrerà sull’impedire attacchi russi agli USA, ai membri della NATO e agli altri partner, rinforzando la nostra determinazione a sostenere le alleanze per includere nella deterrenza le aggressioni convenzionali che hanno il potenziale di portare all’impiego di armi nucleari di ogni livello’. Il riferimento è proprio alle duemila bombe tattiche a disposizione del Cremlino, evocate sempre più spesso nei discorsi dei leader mondiali, che ‘potrebbero venire usate per vincere una guerra sui suoi confini o impedire una sconfitta nel caso in cui si trovasse in pericolo di perdere un conflitto regionale’. Più volte nel dossier le armi atomiche vengono messe sullo stesso piano dei nuovi attacchi convenzionali: non conta più la natura dell’ordigno ma quella degli effetti che può provocare. Questo implicitamente e in alcuni passaggi anche esplicitamente sdogana la possibilità di impiegare le testate nucleari.”
Questo non significa che gli USA (e neppure la Russia o la Cina, se per questo) si preparino a scatenare una guerra nucleare. Riflette invece la rottura dell’equilibrio che la guerra in Ucraina ha messo in luce, così come la natura complessa e globale dello scontro.
Somiglianze e differenze con gli anni ’30
Si pone inevitabilmente la questione: questo conflitto economico e politico può sfociare oltre che nella corsa al riarmo in uno scontro militare su vasta scala? Siamo, come dice il Papa, già entrati nella “terza guerra mondiale”?
Scrivendo nel 1937, poco prima della Seconda guerra mondiale, Trotskij rilevava come il protezionismo e la frantumazione del mercato mondiale in blocchi non conducesse a un equilibrio fra economie chiuse, ma che l’autarchia non era altro che la premessa di una aggressione condotta verso l’esterno. In secondo luogo metteva in luce come come la corsa generale al riarmo fosse da un lato una conseguenza di questo mutato quadro economico e politico e dall’altro conducesse inesorabilmente le grandi potenze del tempo a scontrarsi per il dominio mondiale.
“In nome della pace e dello status quo, la Gran Bretagna si appresta a diventare nei prossimi anni la più forte potenza navale ed aerea. Ma con ciò stesso dà uno sfrenato impulso agli armamenti navali e aerei al di là dell’Atlantico. Questa la strada percorsa dal paese più sazio, più “pacifico”, più democratico, che ha diretto la conferenza sul disarmo: dalla libertà di commercio al protezionismo, dal pacifismo al riarmo. Quali forze terrene potrebbero essere in grado di impedire il passaggio dal riarmo alla guerra?” (3)
Valgono nel mondo di oggi le considerazioni svolte allora, quando indubbiamente si dimostrarono tragicamente corrette?
La risposta non può che essere articolata. Da un punto di vista generale e in ultima istanza non c’è dubbio che la dinamica attuale dei rapporti internazionali, se proseguisse secondo le proprie logiche interne, ossia in base agli sviluppi oggettivi che l’hanno determinata, a un dato momento condurrebbe a uno scontro militare tra le grandi potenze e in primo luogo fra USA e Cina. Non stiamo parlando di una prospettiva a breve termine, ma dello sbocco di un processo. Questo processo è nelle sue prime fasi e prenderà un’intera epoca storica per sviluppare le proprie contraddizioni. Purtuttavia è indiscutibilmente in atto.
Così come il conflitto tra Russia e NATO, dopo quasi vent’anni di schermaglie diplomatiche, mosse e contromosse su teatri di scontro periferici, oggi è arrivato a un salto di qualità con la guerra in Ucraina, anche il conflitto fra USA (e alleati) e Cina è destinato a percorrere una strada simile.
Oggi ne vediamo solo i prodromi: la guerra economica sopra descritta, il tentativo di occupare posizioni di vantaggio, la contesa per l’influenza su decine di regioni e Paesi, dall’Africa centrale, al Pakistan al Myanmar… oltre alla lotta decisiva per il controllo dei mari della Cina e degli Stretti, lotta che coinvolge la questione di Taiwan, ma in futuro chiamerà in causa anche Singapore, la Malesia, l’Indonesia, e che ha come posta in gioco il controllo delle più importanti rotte commerciali del mondo.
La Cina si trova nell’obbligo di modificare una situazione di partenza che la vede fortemente sfavorita, e per questo figurerà come “l’aggressore”, per lo stesso motivo per cui la Germania occupò questa posizione nelle due guerre mondiali, e il Giappone nella Seconda. Ma per quanto le definizioni di aggressore e aggredito abbiano grande importanza nella propaganda e nella diplomazia, da un punto di vista oggettivo assumono un significato del tutto secondario. Tra USA e Cina non abbiamo un aggressore e un aggredito, bensì una potenza dominante che intende mantenere il potere, e una potenza emergente che intende farsi spazio se non addirittura soppiantare la prima. Nessuna delle due può vantare alcun “diritto” in materia, se non quello della forza.
La differenza fondamentale rispetto alla fine degli anni ’30 è che allora il movimento operaio veniva da una lunga serie di sconfitte che lasciavano mano libera alla classe dominante. In Italia e Germania il movimento operaio era schiacciato sotto la dittatura fascista, così come nella gran parte dell’Europa centro orientale, dove prevalevano regimi fascisti o bonapartisti. In Francia e in Belgio i governi di Fronte Popolare avevano profondamente deluso le aspettative della classe operaia che li aveva eletti ed erano passati da una politica di riforme parziali a una di controriforme. In Spagna la guerra civile si avviava a conclusione con la vittoria di Franco. Soprattutto, mancava completamente il fattore soggettivo, ossia una forza si massa del movimento operaio che si battesse coerentemente per una politica internazionalista e di classe. La Seconda Internazionale (socialista) aveva già capitolato allo sciovinismo il 4 agosto del 1914, rinunciando ad opporsi allo scoppio della Prima guerra mondiale e dividendosi su linee nazionali, con ciascun partito che appoggiava lo sforzo bellico delle rispettive borghesie. La Terza Internazionale (comunista), che era stata fondata precisamente in opposizione al tradimento operato dalla socialdemocrazia, era ormai pienamente caduta sotto il controllo della burocrazia stalinista e della sua nefasta teoria del “socialismo in un solo paese”.
Per questo Trotskij era costretto a fare la seguente valutazione:
“Ma ci si può attendere una resistenza contro i pericoli di guerra dal basso, da parte delle masse operaie, sotto forma di scioperi generali, insurrezioni, rivoluzioni? Teoricamente non è escluso. Ma se se non si prendono i propri desideri o i propri timori per realtà, bisogna dire che si tratta di una prospettiva poco verosimile. Le masse lavoratrici di tutto il mondo portano attualmente il peso terribile delle disfatte subite in Italia, in Polonia, in Germania, in Austria, in Spagna, parzialmente in Francia, e in diversi paesi minori. Le vecchie Internazionali (…) sono strettamente legate ai governi degli stati democratici e prendono parte attiva ai preparativi di guerra “contro il fascismo”. È vero che sia i socialdemocratici sia i comunisti hanno un atteggiamento disfattista nei confronti della Germania, dell’Italia e del Giappone: ma ciò significa che lottano contro la guerra unicamente nei paesi in cui non hanno influenza. Per lottare contro il militarismo, le masse dovrebbero prima liberarsi della tutela delle Internazionali ufficiali. Non è una cosa semplice. Non ci si può riuscire né in un giorno né in un mese. Oggi, comunque, il risveglio politico del proletariato avviene con un ritmo più lento di quanto non avvenga la preparazione della nuova guerra.” (4)
La considerazione finale ci porta all’altra differenza fondamentale tra oggi e gli anni ’30: la questione del ritmo di sviluppo degli avvenimenti. Oggi i processi sono molto più indietro e sarebbe futile sensazionalismo prevedere una guerra mondiale nel giro di due anni, come invece del tutto correttamente scriveva Trotskij nel testo citato.
Oggi nella maggior parte dei paesi non è il peso di sconfitte dirette e recenti a frenare l’azione della classe lavoratrice, ma piuttosto il contrario: la necessità di ricomporre le proprie fila, di riconquistare o di creare le proprie organizzazioni di massa come strumenti per la difesa dei propri interessi. Non siamo, come nel 1937 quando scriveva Trotskij, alla fine di una longa ondata di lotte della classe lavoratrice, ma piuttosto sulla soglia di una nuova fase ascendente, di cui le lotte salariali ed economiche che si diffondono da un paese all’altro sono solo una primissima manifestazione.
Non si parla quindi di mesi o anni, ma di tutta una fase storica nella quale il movimento operaio dovrà affrontare le conseguenze della crisi del capitalismo. Il pericolo di guerre e anche la prospettiva di uno scontro su vaste proporzioni che coinvolga anche le principali potenze mondiali non può più essere considerato impossibile. Per essere precisi, è una prospettiva inevitabile se la classe lavoratrice non sarà capace, nell’epoca che si è aperta, di rovesciare il sistema capitalista e il potere della borghesia almeno in alcuni paesi, indicando così all’insieme dell’umanità la strada per uscire dalla barbarie.
Questo articolo non tratta la questione fondamentale di quali conseguenze abbiano i nuovi rapporti internazionali sulla lotta di classe, sugli schieramenti politici interni alla borghesia e sul movimento operaio, aspetti essenziali sui quali torneremo in futuro. Ci fermiamo quindi sulla conclusione basilare che ne segue: la lotta contro la guerra e contro le politiche che conducono alla guerra non può essere combattuta indipendentemente dalla lotta contro il capitalismo.
Note
1. Il testo integrale del documento, da cui sono tratte le successive citazioni e sintesi, è reperibile sul sito della Casa Bianca: www.whitehouse.gov.
2. Le Tesi sull’Ucraina della TMI sono pubblicate sul nostro sito www.rivoluzione.red.
3. Lev Trotskij, “Di fronte a una nuova guerra mondiale”, in Guerra e rivoluzione, Mondadori 1973, pag. 7.
4. Ibidem.

