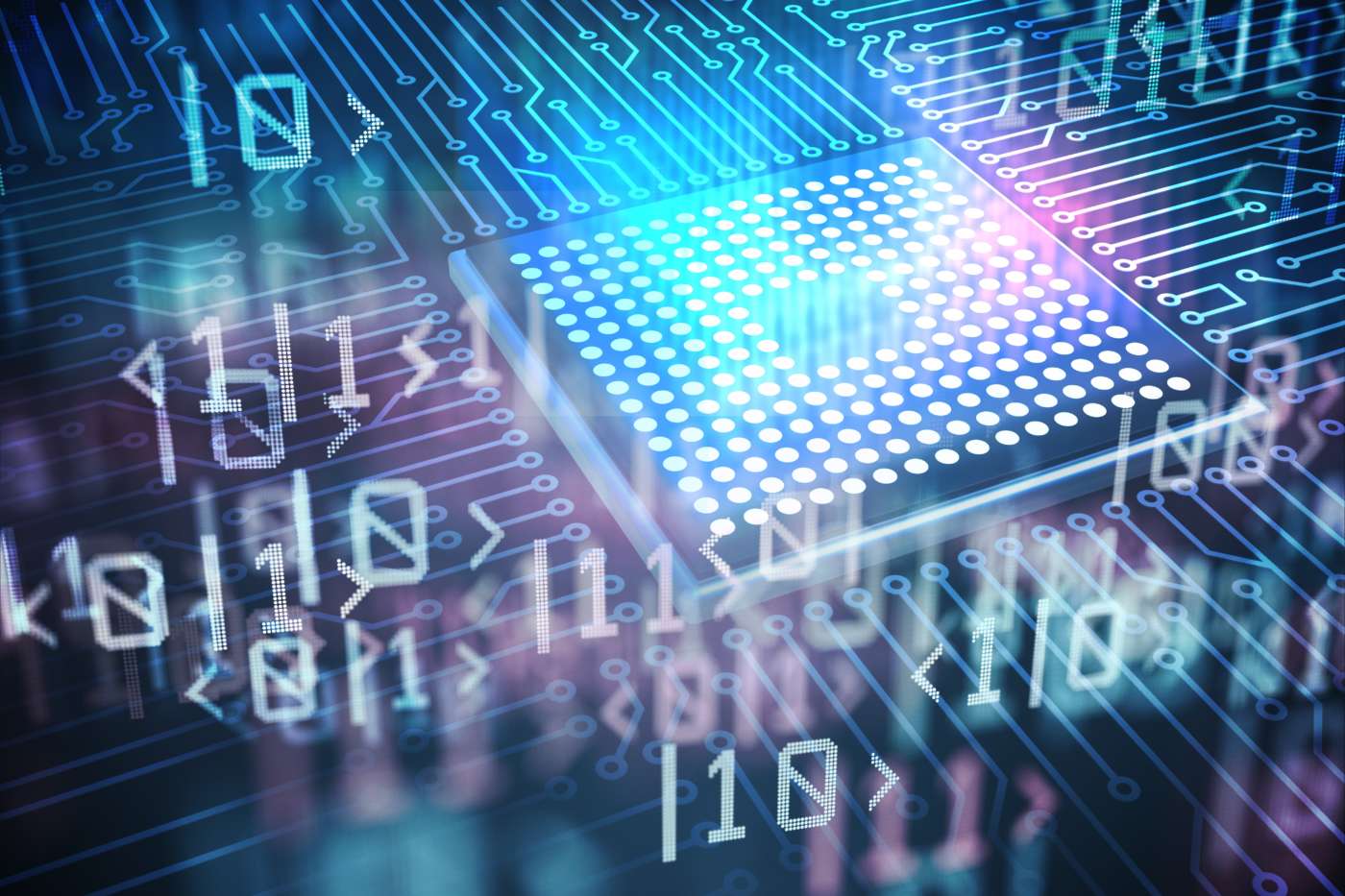
Corsa mondiale alle tecnologie quantistiche
18 Marzo 2025
Argentina – Pensionati, lavoratori e tifosi si mobilitano in massa nonostante la repressione. Mandiamoli tutti a casa! Che governino i lavoratori!
18 Marzo 2025Campi Flegrei – Serve un vero piano di sicurezza. Vogliamo vivere in luoghi sicuri, non vogliamo bombe!

di Leonardo De Lorenzo e Livio Barbagallo
“Se arriva una scossa di quinto grado crollano i palazzi e si contano i morti”, queste sono state le parole del capo della protezione civile Fabio Ciciliano in risposta ad un ragazzo che chiedeva quali misure sarebbero state prese dopo le scosse particolarmente forti registrate tra il 16 ed il 17 febbraio scorso.
La crisi bradisismica dei Campi Flegrei, ricominciata nel 2005, negli ultimi anni sta attraversando una fase di maggiore intensità. La scossa datata 13 marzo, di magnitudo 4.4, ha interessato non solo i Campi Flegrei ma anche zone più distanti della città di Napoli, portando paura e sgomento tra la popolazione (specialmente coloro che hanno sperimentato per la prima volta l’effetto di tale crisi), che, a ragione, è totalmente insoddisfatta dei piani confusi e carenti messi in campo dalla protezione civile e delle istituzioni politiche locali.
Tuttavia, è importante analizzare tale fenomeno e comprendere quali devono essere le risposte comprendendo a livello scientifico cosa sta succedendo, senza scadere né in un panico irrazionale né tantomeno nella sottovalutazione del fenomeno.
Cos’è il bradisismo? Si tratta di un fenomeno legato al vulcanismo consistente in un periodico abbassamento (bradisismo negativo) e innalzamento (bradisismo positivo) del livello del suolo, particolarmente lento se relazionato ai tempi della vita umana ma abbastanza rapido se misurato in tempi geologici. La fase di bradisismo positivo, che è il fenomeno in corso nella zona flegrea dal 2005, provoca la creazione e l’intensificazione dei terremoti. Queste scosse, a differenza di quelle create dalle zone di faglia, raggiungono un’intensità massima di magnitudo di circa 5.0 gradi, come affermato da diversi studi e ricercatori.
Non è un fenomeno esclusivo della zona dei Campi Flegrei (un altro esempio è la caldera nella Long Valley della Sierra Nevada), ma la situazione nell’area partenopea è alquanto particolare. Infatti, la caldera sottostante si estende per circa 15 chilometri e nel corso della sua storia geologica ha prodotto eventi di natura molto rilevante come l’ignimbrite campana di 39.000 anni fa o, più recentemente, l’eruzione del Monte Nuovo avvenuta il 28 settembre del 1538 (che ha provocato il ritiro del mare di 370 metri, corrispondente ad un moto bradisismico di circa 7,4 metri). In tempi ancor più recenti, crisi bradisismiche che hanno interessato la zona ci sono state nel ’70-’72 e nell’’83-’84, quando il Rione Terra di Pozzuoli ha fatto registrare un aumento del sollevamento del suolo di 1,13 metri.
Fortunatamente, non vi sono prove di rischio di eruzione imminente, dato che non è stata rilevata alcuna risalita di magma, ma solo quella di gas ed altri fluidi vulcanici per via del degassamento del suolo che si produce in concomitanza con l’innalzamento. Difatti, è recente la notizia secondo cui il fenomeno stia liberando dal suolo enormi quantità di gas quali anidride carbonica (di cui il 40% rilasciata dalle rocce calcaree sottostanti che entrano in contatto con i fluidi magmatici) ed anidride solforosa, che se inalate in grandi quantità e in ambiente chiuso possono essere pericolose. Motivo per cui è aumentata la preoccupazione in edifici sovraffollati, alcuni dei quali sono stati resi momentaneamente inagibili (come il liceo Virgilio di Pozzuoli). Oltretutto, l’intensità del sollevamento (e di conseguenza lo sviluppo dei terremoti) è stata maggiore, e nel mese di febbraio la media di rialzo del suolo è passata da 1-1,5 cm a 3 cm, provocando le recenti scosse di oltre 3.0 di magnitudo avvertite dalla popolazione.
“Dobbiamo essere sinceri non si può giocare con le parole: le case non saranno mai messe al sicuro al 100 per cento, si può lavorare in qualche edificio per mitigare le conseguenze di una eventuale scossa violenta”, così ha detto il ministro per la Protezione civile e del mare, Nello Musumeci, durante uno degli ultimi incontri sull’emergenza. In questi giorni il comune di Napoli e quello di Pozzuoli hanno pubblicizzato la possibilità per i cittadini di richiedere un sopralluogo gratuito per la verifica della “conformità edilizia”.
Se da una parte il ministro ammette candidamente di non avere alcuna soluzione per la messa in sicurezza, dall’altra l’amministrazione regionale e comunale si offre di fare singole verifiche agli edifici su richiesta dei cittadini, come ad ignorare lo stato in cui versa l’edilizia, non solo della zona flegrea. Secondo l’ultimo censimento degli edifici, reperibile sul sito del comune di Napoli e datato 2011, il 21,5% degli edifici è stato costruito prima del 1919, circa il 13% tra il primo e il secondo dopoguerra e solo il 4% dopo il 2005 e rispetto allo stato di conservazione, a fronte del solo 8% classificato in ottimo stato, oltre il 39% è considerato in condizioni mediocri o pessime. Gli edifici pubblici non sono da meno. I 200mila euro stanziati dal comune di Napoli per la verifica degli edifici scolastici sono solo briciole se messe a confronto con le condizioni in cui versano scuole ed università; è notizia di pochi giorni fa il crollo di un solaio all’interno di una delle aule di Ingegneria della Federico II avvenuta durante gli esami e che solo per puro caso non ha ferito nessuno. Questo crollo, come le continue cadute di cornicioni che avvengono dappertutto in città durante le giornate di vento, non sono frutto della forza della natura, ma solo dell’incuria e della incapacità di questo sistema a garantire la sicurezza minima della popolazione.
Mentre il governo si ripromette di aumentare la spesa militare fino al 2% del Pil, e il governatore De Luca presenta un investimento da 700 milioni di euro di “riqualificazione della zona est” con il faraonico progetto della nuova sede della Regione per far fede al suo smisurato ego e per fare affari con i palazzinari, a nessuno interessa davvero la condizione di precarietà di centinaia di migliaia di famiglie che vive l’emergenza bradisismo con costante apprensione e corrette preoccupazioni. Invece di spendere soldi in armi e in speculazioni edilizie devono essere investiti fondi per la immediata messa in sicurezza degli edifici e per dotarli di tutte le condizioni minime per le norme antisismiche.
Anche la gestione delle emergenze è assolutamente in ritardo e si maschera dietro la imprevedibilità del fenomeno. Se, di fatti, nessuno può prevedere quando avverrà un terremoto e con che intensità, è pur vero che in questa fase di crisi bradisismica le scosse sono quotidiane e costanti e creano paura e stress nella popolazione che sempre più spesso si riversa in strada o preferisce non dormire nelle proprie case. Il piano delle aree di attesa si è limitato a disseminare la città di paline che indicano dove stazionare in caso di emergenza senza fornire alcun servizio reale alla popolazione. Soltanto le prime proteste degli abitanti di Pozzuoli e Bagnoli hanno dato una reale accelerata alla situazione; poco dopo la scossa di 4.4 gradi, la più forte e significativa da quarant’anni a questa parte, i bagnolesi hanno rivendicato a gran voce l’utilizzo della Ex Base Nato come luogo di rifugio per la notte (si tratta di una struttura enorme che ha aree dormitorio e bagni) ottenendo la apertura di questo spazio. In particolar modo in tutta l’area flegrea queste aree di attesa devono essere trasformate in aree di accoglienza che possano fornire soccorso e strutture di prima necessità.
La zona flegrea è in piena emergenza, negli ultimi giorni si sono succedute ben tre scosse superiori ai 3,5 gradi e i danni, se pur non ingenti, iniziano a contarsi con varie case dichiarate inagibili: ad oggi 184 persone sono state allontanate dalle loro case. La risposta del governo è un misto di fatalismo e interventismo vero o presunto, attraverso un piano che prevede tre scenari relativi al rischio terremoto e lo scenario, per ora non all’ordine del giorno, dell’eruzione della caldera. Nel caso più grave di una scossa che arrivi al 5°grado vi è un piano di allontanamento della popolazione dalle zone rosse (in cui vivono circa 500mila persone). Questo piano si limita a prevedere un intervento successivo ad una scossa e avrebbe attuazione solo nel caso in cui il terremoto interrompesse i servizi essenziali. Il piano sicurezza riguardante l’eventuale allontanamento dei cittadini dalle zone rosse è in gravissimo ritardo e Ciciliano ha dichiarato che serve ancora un anno per poter aprire delle vie di fuga sicure…
Non c’è tempo per alcun tipo di indugio e non siamo disposti a sentire le lacrime di coccodrillo da parte del governo; urge un piano che dia risposte immediate alla popolazione e che permetta di individuare vie di fuga sicure per raggiungere le aree di emergenza e la possibilità per i soggetti fragili di avere già da oggi una struttura alternativa e sicura nella quale alloggiare.
Solo la lotta popolare può costringere il cinismo delle istituzioni a cambiare rotta rispetto al controllo del rischio e deve essere organizzata da comitati dotati di un programma che punti alla messa in sicurezza di tutto il territorio (anche della zona gialla la cui popolazione è vicina al milione), affinché la prevenzione non sia lasciata nelle mani di sciacalli e speculatori.
Alcune rivendicazioni essenziali come la creazione in ogni quartiere e comune coinvolto di aree di accoglienza, la messa in sicurezza degli edifici e alloggi dignitosi per gli sfollati devono essere il punto di partenza per un cambio radicale nella gestione della vicenda.
La frustrazione degli abitanti della zona flegrea deve trasformarsi in rabbia e lotta contro questo sistema e la sua classe dominante, che mette il profitto davanti a ogni cosa, perfino alla vita umana. I soldi si prendano dalle spese militari, vogliamo vivere in luoghi sicuri e non vogliamo bombe, dai palazzinari e dagli speculatori, che hanno fatto lauti profitti nel settore immobiliare della zona flegrea.
