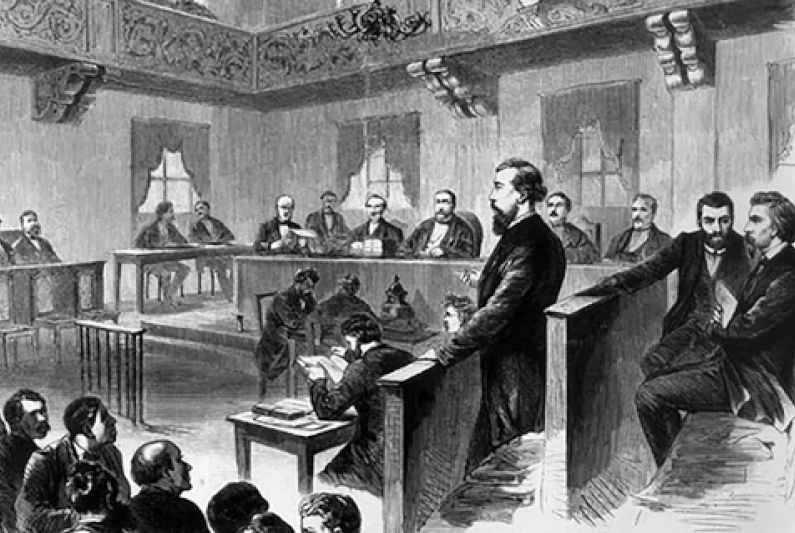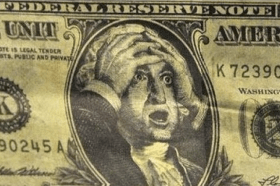
I piedi d’argilla del gigante americano
29 Settembre 2025
“I portuali non lavorano per la guerra” – L’incontro internazionale dei portuali a Genova indica la via
6 Ottobre 2025di Emanuele Nidi
Nel 1875 fu annunciato nella città di Gotha il congresso di unificazione dell’Associazione operaia generale tedesca, formata dai seguaci di Ferdinand Lassalle, e del Partito operaio socialdemocratico, vicino a Marx ed Engels. Questi ultimi, quando lessero la bozza del programma in discussione al congresso, rimasero scandalizzati. I dirigenti socialdemocratici, pur di arrivare all’unità, avevano completamente capitolato alle concezioni lassalliane. Marx scrisse un breve commento, passato alla storia come Critica al programma di Gotha. Dalla stesura di quelle note sono trascorsi 150 anni. L’anniversario offre il pretesto per tornare a questo scritto di straordinario valore teorico.
Marx contro Lassalle
Lassalle fu uno dei principali dirigenti del movimento operaio tedesco. Morì in un duello nel 1864, ma le sue idee mantennero una grande influenza. Il fine ultimo dei lassalliani era la redistribuzione della ricchezza prodotta dalla società (quella che definivano con un’espressione scorretta “reddito integrale del lavoro”), un obiettivo che dal loro punto di vista poteva essere conseguito solo dallo Stato, al vertice di un sistema di cooperative operaie.
Questa concezione, che non aveva nulla a che spartire con il marxismo, era stata completamente introiettata nel programma di Gotha. Nelle sue note Marx ne denuncia la superficialità teorica, il dilettantismo economico e la mancanza di una prospettiva internazionalista. Inoltre, ed è questo punto a costituire la specificità del testo all’interno della letteratura marxista, traccia le coordinate per un’analisi materialista della futura società comunista.
Distribuzione e rapporti di produzione
L’argomento non è usuale per Marx, che aveva sempre criticato la tendenza dei socialisti a fantasticare sulle caratteristiche del comunismo. Ma le circostanze imponevano alcune chiarificazioni, senza peraltro cedimenti all’utopismo: per Marx è chiarissimo che la nuova società non si svilupperà dal nulla, ma nascerà dalle doglie del capitalismo, recando ancora i segni del vecchio mondo sotto ogni aspetto, “economico, morale, spirituale”. Questo avrà determinate conseguenze sul piano dell’organizzazione della società.
I redattori del programma di Gotha avevano dato grande centralità alla rivendicazione di una giusta distribuzione della ricchezza. Al netto degli errori di forma su cui Marx si scaglia impietosamente, c’è un problema sostanziale. È possibile considerare la distribuzione indipendentemente dal modo di produzione?
Nel capitalismo, sulla base della proprietà privata dei mezzi di produzione, la distribuzione non può che essere il riflesso dei rapporti economici tra il padronato e la classe lavoratrice. Conseguentemente una “giusta” distribuzione della ricchezza (o, per essere più precisi, dei mezzi di consumo) cadrà invariabilmente a favore della minoranza proprietaria. Solo rovesciando questo sistema e istituendo la proprietà collettiva dei mezzi di produzione si potrebbe arrivare a una distribuzione effettivamente egualitaria.
Eppure, per Marx i problemi non si esauriscono qui. Quello preso in esame non è il “comunismo” in astratto, ma una formazione sociale calata nella storia con le radici nel vecchio sistema capitalista. In una prima fase, quando il livello economico e culturale non si è ancora innalzato a sufficienza, i criteri distributivi rimangono quelli borghesi, secondo cui ogni lavoratore riceve una forma di retribuzione proporzionata al carico di lavoro svolto. La norma è imparziale (il lavoro è calcolato per tutti nello steso modo e, a differenza che nel capitalismo, non ci sono distinzioni di classe) ma non prende in considerazione le caratteristiche fisiche e psicologiche o le condizioni famigliari di ciascuno, che fanno sì che lo stesso lavoro pesi in modo differente su spalle diverse. Si tratta quindi, nella profonda espressione di Marx, di un “diritto della disuguaglianza, come ogni diritto”, un residuo di un passato da superare non appena possibile. Si noti l’approccio scrupoloso del teorico comunista nei confronti delle necessità individuali e lo si confronti con la mortificazione delle aspirazioni dei singoli cittadini delle “individualiste” società capitaliste!
La dittatura del proletariato
In questa fase inferiore del comunismo, che i marxisti definiranno “socialismo”, lo Stato ha ancora un ruolo da giocare. Marx era particolarmente sdegnato per l’introduzione, nel programma di Gotha, della rivendicazione lassalliana di uno “Stato libero”. Dal punto di vista marxista, lo Stato non è un’entità neutrale, ma una forza repressiva a difesa di determinati rapporti di proprietà. Le leggi sarebbero carta straccia senza una polizia che le facesse rispettare. Da questo punto di vista, l’unica libertà di cui uno Stato “libero” può godere è la libertà di reprimere.
Ma cosa ne sarà dello Stato dopo la rivoluzione? Il vecchio Stato, quello capitalista, deve essere abbattuto. Proprio perché non si tratta di un organismo neutrale, non può essere utilizzato a proprio piacimento, come pensava Lassalle. Ma uno Stato esisterà ancora, perché ci sarà ancora bisogno di una forza repressiva, in primo luogo contro i difensori del vecchio regime. La “dittatura rivoluzionaria del proletariato” assolve a questo scopo, per quanto in modo molto diverso dai domini di classe che l’hanno preceduta. Basandosi su forme di democrazia sempre più compiute (Marx aveva in mente l’esempio recentissimo della Comune di Parigi), dissolve il suo potere; man mano si sviluppa nell’autogoverno dei lavoratori, fino all’estinzione della società di classe in quanto tale e quindi dello Stato, trasformato nel frattempo “da organo sovraordinato alla società in organo completamente subordinato a essa”.
Questo modello non ha niente a che vedere, nemmeno nelle sue prime fasi, con quello poliziesco che caratterizzerà i regimi stalinisti. Al contrario, il peso della burocrazia viene, come sottolinea Marx, “ridotto sin dall’inizio in modo considerevole” rispetto alla vecchia società. Il presupposto non è la collettivizzazione della miseria, ma la libera espressione di tutto il potenziale tecnico e culturale soffocato dal sistema capitalista. Si pongono così le fondamenta per una produzione su basi razionali e democratiche e, finalmente, per un’organizzazione della distribuzione basata sul principio autenticamente comunista, che nelle pagine della Critica al programma di Gotha trova la sua formulazione più conosciuta: “da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni”.